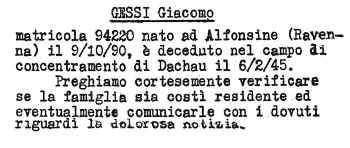|
La mia
famiglia era proprietaria di un bar ad Alfonsine la cui clientela era
formata prevalentemente da braccianti, muratori, artigiani e contadini.
Era considerato il più attrezzato; c’era la sala biliardo, la
radio-giradischi e la gelateria. Si trovava nella piazza, dove ce n’erano altri tre:
il Caffè del Fascio (detto “Cafè d’la Beatriz”, situato
all’angolo della piazza, dalla parte opposta al nostro); il caffè
"d’la Niculena", e “Frazché”.
Il nostro bar, detto
“Caffè d’Cai”, aveva la nomea di essere un covo antifascista e
sovversivo; infatti, la maggioranza dei clienti non era fascista, e ogni
giorno facevano vivaci discussioni sull’andamento della guerra, sulle
vittorie che l’Asse, nei primi mesi, otteneva sui campi di battaglia,
cosa questa che li lasciava amareggiati.
Me
li ricordo ancora tutti i nostri clienti di allora, potrei menzionarli
uno ad uno con i loro soprannomi, farei un elenco molto lungo, ma temo
che, se ne lasciassi indietro qualcuno, mi dispiacerebbe. Questi clienti
manifestavano apertamente le loro idee: c’erano repubblicani,
comunisti, socialisti ed anche cattolici, discutevano sulla guerra e sul
pericolo della vittoria nazi-fascista. Avevo imparato a conoscerli fin
da piccolo, quando andavo alle elementari e mio padre era ancora al
mondo. Nelle sere d’inverno, quando si raccoglievano attorno alla
stufa, i più anziani iniziavano a discutere raccontando le vicende
della prima guerra mondiale e i fatti di quell’immediato dopo guerra. Riferendosi poi all’avvento del fascismo, raccontavano gli episodi che
erano accaduti nel paese, dalla distruzione e dall’incendio dei circoli
socialista repubblicano, e del teatro “e’ baracò” dei Gessi, a vari episodi
contro il nostro caffè, alle bastonature e agli assassinii di gente
onesta, colpevole solo di non avere aderito al fascismo. raccontare di un gravissimo episodio avvenuto nella bottega
“Sale e tabacchi” sotto il porticato, prima della rampa del fiume.
Abele Faccani,
segretario del partito fascista di Alfonsine, insieme al fratello, aggredì
Mino Gessi, mentre entrava in tabaccheria. Questi era membro di una
famiglia di tendenza liberale e benestante, da qualche tempo in odio ai
fascisti locali. Il Gessi che girava sempre armato per difendersi da
eventuali aggressioni fasciste, fu buttato violentemente per terra e
malmenato, ma riuscì, con le due pistole che portava sotto il mantello
(la “caparèla”), a colpire a morte Abele Faccani e a ferire
l’altro. Ferito a sua volta, si rifugiò in alcuni casolari di
contadini, e fu aiutato a scappare in Francia. Là svolse attività
antifascista.
|

....
Da sempre, li sentivo fare vivaci discussioni, fin dai giorni in cui
il fascismo era salito al potere....

..
nella bottega “Sale e tabacchi” sotto il porticato, prima della
rampa del fiume...

...
fu aiutato a scappare in Francia. Là svolse attività antifascista...
Mino Gessi negli anni
dell'esilio in Francia

Mino
Gessi a sinistra con Primo Babini
(e’ Pepa) a Nizza a cavallo degli anni '20-'30.
La Lancia Lambda è di
Mino, acquistata dopo anni di lavoro, con la quale faceva servizi, per
campare.

Cagnes-sur-Mer (Nizza) :
la lapide, dedicata ai resistenti morti per la patria, porta anche il nome
di Giacomo (Jacques) Gessi.
I Francesi, a pochi anni dalla fine della
guerra (1948),
dettero a Gessi questo onore.
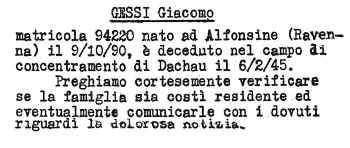
|
|
Solo nel dopoguerra si seppe della sua tragica morte:
Gessi nel gennaio 1942 era stato arrestato dai fascisti francesi del
governo collaborazionista di Vichy, e incarcerato nel campo
d’internamento a Vernet; poi nell’estate del 1944 fu deportato come
prigioniero politico dai tedeschi a Dachau, dove morì di malattia. Il
suo corpo finì in un forno crematorio, nel febbraio del 1945.
Non era mai più
ritornato né in Italia, né ad Alfonsine.
Ma
il mito di Mino Gessi si era talmente radicato, soprattutto tra la gente
povera, che ogni tanto circolavano voci di qualcuno che l’aveva visto
in paese. Chi al funerale del padre, nel ’36, chi vestito da frate
aggirarsi tra le case del borgo detto “e’ Lazzarètt”. Io stesso
ho creduto di averlo visto coi miei occhi, un giorno del 1943. Era
venuto un signore nel mio bar a prendere un caffè. Un gruppo di clienti
gli si era radunato attorno, sembravano tutti eccitati.
Mia
madre mi disse che quello era Mino Gessi
|

inizio pagina
|
Il
pestaggio di Gusto d’Cabarièl
|
I
fascisti locali attuavano molte “azioni punitive” come questa, a volte
aiutati da gruppi di camerati provenienti dai vicini paesi ferraresi, (Argenta,
Portomaggiore). In quelle
tragiche giornate, lo venni a sapere dai racconti serali al bar, anche il nostro
“Caffè” era stato distrutto, incendiato e saccheggiato per ben tre volte, e
a mio padre e mio zio, quando avevano denunciato ai carabinieri le persone
riconosciute mentre stavano incendiando il bar, era stato risposto che purtroppo
non si poteva intervenire, perché i colpevoli erano capi fascisti; nel caso di
mio padre la sola colpa era di essere un socialista. A quegli episodi se ne
aggiunsero altri: il licenziamento in tronco di mio padre, impiegato
nell’ufficio tecnico del comune, solo perché si rifiutava di prendere la
tessera del fascio.
Molti
clienti del bar furono ricattati per lo stesso motivo e persero anch’essi il
lavoro, ma nonostante ciò avevano ancora il coraggio di difendere le proprie
idee in privato e anche in pubblico, pur consapevoli di andare incontro a seri
pericoli per sé e per la propria famiglia. Per difendersi dalle spedizioni
punitive fasciste, queste persone si riunivano per affrontare insieme il
pericolo di eventuali scontri, che potevano avere luogo lungo la strada. Così
non arrivavano al caffè mai singolarmente, ma in gruppo: c’era il gruppo del
Borgo Gallina, del Borgo Seganti, del Taglio Corelli, del Fiumazzo, delle Borse
e del Borghetto. Arrivavano al “Cafè d’Cai” per incontrarsi e svagarsi un
po’ insieme; per parlare della situazione e tenere sempre viva la questione
dell’antifascismo. Era gente umile, coi calli sulle mani, di poche parole, ma
quello che diceva mi colpiva, e rimanevo ammirato dal coraggio morale che aveva.
Andavo a letto turbato. Mi ricordo che, sempre in quel periodo, una sera dopo
cena, mentre, ancora bambinetto, giocherellavo con Paicca (era il soprannome di
un ragazzo sulla ventina che si chiamava Mario, abitava nei Sabbioni, amico di
mio fratello), entrò un anziano cliente di nome Gusto d’Cabarièl, uno dei
pochi anarchici rimasti, che aveva capeggiato nel 1914 la rivolta della
“Settimana Rossa” di Alfonsine. Gusto stava bevendo il caffè che gli aveva
preparato mio fratello maggiore Mino, quando entrarono quattro o cinque giovani
alfonsinesi, studenti universitari, in camicia nera perché probabilmente quello
era il giorno di una ricorrenza fascista, forse il 22 ottobre.
Si
avventarono su Gusto imponendogli di intonare “Giovinezza, Giovinezza”. Lui
impaurito, rispose di non saper cantare, ma loro insistettero e uno gli allungò
uno scapaccione, facendogli cadere il cappello dalla testa. Quando lui si chinò
per raccoglierlo ricevette un calcio che lo fece barcollare, e, tra calci,
scapaccioni e spinte, lo fecero arrivare in mezzo alla piazza, lasciandolo lì
per terra. Tutti nel bar assistettero attoniti a quella vile e selvaggia
mascalzonata. Io, rivolgendomi a Paicca, chiesi quasi terrorizzato. “Perché?”
Ma lui, che pure era fascista, con la faccia contratta, restò fermo senza
guardarmi e non disse una parola.

inizio pagina
Quand’ero
bambino
Vorrei
ricordare anche un altro episodio che colpì la mia sensibilità di bambino: una
sera, assieme a qualche amico, andammo al cinematografo, il Cinema Teatro
Aurora, che si trovava a cinquanta metri da casa mia. Quella sera proiettavano
"Il segno della croce", un film in costume ambientato in epoca romana.
Eravamo nelle prime file vicino allo schermo quando, nell’intervallo fra il
primo e il secondo tempo, irruppe nella sala un gruppo di alfonsinesi in camicia
nera, abbastanza eccitati, che si sedettero nella fila davanti alla nostra.
Noi
giocavamo facendo qualche schiamazzo e dicendo qualche parolaccia: le solite
cose che si fanno a quell'età. Ad un certo momento, Romanino, l’amico che
sedeva vicino a me, fece una scherzosa pernacchia rivolta a noi. Il più anziano
di quei signori, uno dei gerarchi fascisti di Alfonsine, rivolgendosi
brutalmente al mio amico in dialetto gli chiese, con fare brusco:
“Di
chi sei figlio?” Lui rispose timoroso: “Sono figlio di Cavina e d’la Seraféna”.
Il
padre era un antifascista rifugiatosi in Francia, costretto a lasciare la
propria famiglia ad Alfonsine. Alla sua risposta quello gli allungò di scatto
un manrovescio. Io rimasi impietrito per la violenza di quel gesto; dalla paura
sgattaiolai fuori e ritornai a casa. Ricordo che mio padre si trovava dietro il
bancone del bar e mi chiese:
“Cos’hai
fatto?” Glielo
raccontai. Poi svelto, svelto andai a letto tremante e impressionato.

inizio pagina
|