|
|
Ricerche
sull'anima di Alfonsine
|
Loris Pattuelli

per la posa in opera dei falsi
cassonetti

tout
commencement
est petit
Joseph
Joubert




one
two free

four five six seven
La
poesia è la solitudine senza distanza tra l’affaccendarsi di tutti.
René
Char
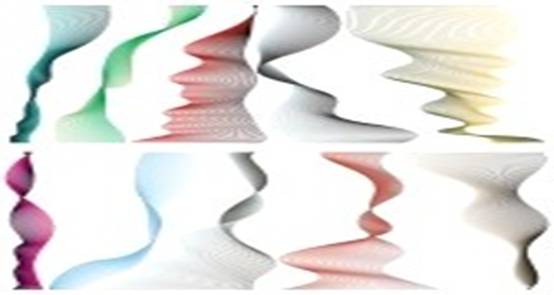
un
luogo nel tutto
Osip
Mandel’stam

Dove
non passano i carri pesanti, là devi camminare. Non spingere il tuo
cocchio dietro impronte altrui, ma segui la tua strada. Non per la via
larga, ma per sentieri non calpestati, muovi il tuo passo. E’ dalla
stretta carraia, dalla strada più angusta che comincia il viaggio.
Callimaco

|
Qualcuna
delle voci
sempre angeliche
-si tratta di me,-
si spiega acerbamente:
queste mille domande
che si ramificano
non danno in fondo,
che ebbrezza e follia;
riconosci questo giro
così facile, lieto:
è solo onda, flora,
ed è la tua famiglia!
poi ella canta. Oh,
così facile, lieto,
e visibile a occhio nudo...
-e io canto con lei, -
riconosci questo giro
così facile, lieto,
è solo onda,flora,
ed è la tua famiglia!...ecc...
e poi una voce
-com’è angelica!-
si tratta di me,
ci spiega acerbamente:
e subito canta,
sorella dagli aliti:
con tono tedesco,
ma ardente e piena:
il mondo è vizioso;
e tu ti stupisci!
vivi e lascia al fuoco
l’oscuro infortunio.
oh! bel castello
com’è chiara la tua vita!
quale età è la tua,
natura sovrana
del nostro fratello maggiore; ecc...
e
canto anch’io:
molteplici sorelle; voci
per nulla pubbliche!
circondatemi
di gioia pudica... ecc...
Arthur Rimbaud
|
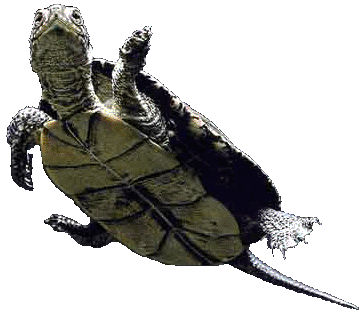 |
Ho come la sensazione che al giorno
d’oggi non si abbia “proprio più”, o forse, per dirla meglio, “non
ancora” il diritto di comportarsi e di esprimersi “poeticamente”.
Robert Walser
  
Il
Grande Capo di Washington vuole comprare la nostra Terra. Mi sembra una
proposta amichevole, gentile e piena di buona volontà, perché la
nostra terra lui può prenderla anche con i fucili. Quello che dice il
Capo Seattle, il Grande Capo di Washington deve considerarlo sicuro, così
come sicuro è il ritorno delle stagioni. Le mie parole sono stelle che
non tramontano mai. Ma come potete comprare o vendere il cielo e il
tepore della terra? L’idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la
freschezza dell'aria e lo scintillio dell'acqua, come potete voi
comprarli? Ogni zolla di terra è sacra per il mio popolo. Ogni ago di
pino, ogni spiaggia sabbiosa, ogni goccia di rugiada, ogni insetto
ronzante è sacro per la mia gente. La linfa che circola negli alberi
porta le memorie dell’uomo rosso. I morti dell’uomo bianco
dimenticano il paese dove sono nati quando girano tra le stelle. Noi
siamo parte della terra e la terra è parte di noi. I fiori profumati
sono nostri fratelli. Il cervo, il cavallo e l’aquila sono nostri
fratelli. Le creste rocciose, il verde dei prati, il calore dei pony e
l’uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. Considereremo la
vostra offerta, ma non sarà facile perché questa terra per noi è
sacra. L’acqua che scorre nei torrenti e nei fiumi non è soltanto
acqua, ma anche il sangue degli antenati. Se vendiamo la nostra terra,
voi dovete ricordare che essa è sacra e dovete insegnare ai vostri
figli che ogni riflesso sulla superficie dei laghi racconta la vita
della mia gente. Il mormorio dell'acqua è la voce del padre di mio
padre. I fiumi sono nostri fratelli, trasportano le nostre canoe e
nutrono i nostri bambini. Se decidiamo di vendervi la terra, voi dovrete
trattarla come una sorella. Le ceneri degli antenati sono sacre, e così
questa collina e questi alberi. Per noi tutta la terra è sacra.
Sappiamo che l’uomo bianco non capisce questi pensieri. Per lui un
pezzo di terra vale un altro pezzo di terra. Come uno straniero arriva
all’improvviso,
prende quello che gli serve, e scappa via. La terra non è sua
amica, ma un trofeo da mostrare. Tratta sua madre (la terra) e suo
fratello (il cielo) come cose che possono essere comprate, sfruttate e
vendute. La sua ingordigia divorerà tutto quanto e dietro di lui non
resterà che il deserto.
Quello che io so è che abbiamo pensieri diversi. La vista delle
vostre città ferisce gli occhi dell’uomo rosso. Non c’è un posto
tranquillo nelle città dell’uomo bianco. Non esiste in esse un luogo
dove sentire il ronzio di un insetto o lo schiudersi delle gemme in
primavera. Ma forse ciò avviene perché l’uomo rosso è un selvaggio
e non comprende. Il rumore delle città ferisce le sue orecchie. E che
cosa è mai la vita, se un uomo non può ascoltare il grido solitario
del succiacapre o i discorsi delle rane attorno a uno stagno quando si
fa sera? L’aria è preziosa per l’uomo rosso, poiché tutte le cose
sono parte dello stesso respiro. L’uomo bianco sembra non accorgersi
dell’aria che respira e, come un moribondo, è insensibile al fetore
che produce. Se vendiamo la nostra terra, voi dovete ricordare che
l’aria è preziosa per noi e che ha anche lo stesso spirito della vita
che essa sostiene. Il vento che ha dato ai nostri padri il primo alito
riceve anche il loro ultimo respiro. E se vendiamo la nostra terra, voi
dove conservarla come una cosa sacra, come un posto dove anche l’uomo
bianco può andare a gustare il vento e le fragranze dei prati.
Prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma qualora dovessimo
accettare io porrò una condizione: l’uomo bianco dovrà rispettare
gli animali che vivono su questa terra come se fossero suoi fratelli. Io
sono un selvaggio e non conosco altro modo di vivere. Ho visto migliaia
di bisonti marcire sulla prateria, lasciati lì dall’uomo bianco dopo
che un treno in corsa li aveva travolti. Io sono un selvaggio e non
comprendo come un cavallo di ferro sbuffante possa essere più
importante dei bisonti. Che cosa è l’uomo senza animali? Se tutti gli
animali sparissero, noi moriremmo di solitudine. Perché ciò che accade
agli animali accade anche all’uomo. Tutte le cose sono collegate.
Dovete insegnare ai vostri figli che il terreno sotto i loro piedi è la
cenere dei nostri antenati, dite loro che essa è ricca della vita della
nostra gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato
ai nostri, che la terra è la madre di tutti noi. Qualunque cosa capita
alla terra, capita anche ai figli della terra. Sputare sulla terra
significa sputare su se stessi. Questo noi sappiamo: non è la terra che
appartiene all’uomo, ma è l’uomo che appartiene alla terra. Non è
stato l’uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un
filo. Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. Vogliamo
prendere in considerazione la vostra offerta di andare nella riserva che
avete preparato per il mio popolo. Noi vivremo per conto nostro e in
pace. I nostri figli hanno visto i loro padri umiliati nella sconfitta.
I nostri guerrieri hanno provato vergogna. E dopo la sconfitta, essi
passano i giorni nell’ozio e contaminano i loro corpi con cibi dolci e
bevande forti. Poco importa dove passeremo il resto dei nostri giorni:
non saranno molti. Ancora poche ore, ancora pochi inverni, e nessuno
verrà più a pregare sulle tombe degli antenati. Ma perché dovrei
piangere la scomparsa del mio popolo? Le tribù sono fatte di uomini,
niente di più. Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare.
Neanche l’uomo bianco, il cui dio cammina e parla con lui da amico ad
amico, sarà mai libero da questo destino comune. Può darsi che siamo
fratelli, dopo tutto. C’è una cosa che noi sappiamo e che forse
l’uomo bianco scoprirà presto: il nostro dio è il suo stesso dio. Può
darsi che ora voi pensiate di possederlo, così come pensate di
possedere la nostra terra. Non è possibile. Egli è il dio dell’uomo
e la sua compassione è uguale per l’uomo rosso come per l’uomo
bianco. Questa terra è preziosa per lui e disprezzare la terra è come
disprezzare il suo creatore. Anche gli uomini bianchi passeranno, forse
prima di altre tribù. Continuate a contaminare il vostro letto e una
notte soffocherete nei vostri stessi rifiuti. Stiamo prendendo in
considerazione la vostra proposta di acquisto. Se accetteremo, sarà per
assicurarci la riserva che ci avete promesso. Lì forse potremo vivere
gli ultimi nostri giorni come desideriamo. Questo destino è un mistero
per noi, poiché non capiamo perché i bisonti saranno massacrati, i
cavalli selvatici tutti domati, gli angoli segreti della foresta pieni
dell’odore di molti uomini, la vista delle colline rovinate dai fili
del telegrafo. Dov’è la
boscaglia? Sparita. Dov’è l’aquila? Sparita. E che cos’è
dire addio al cavallo e alla caccia? La fine della vita e l’inizio
della sopravvivenza. Quando l'ultimo uomo rosso se ne sarà andato dalla
faccia della terra, quando la sua memoria fra gli uomini bianchi sarà
diventata un mito, queste riserve brulicheranno degli invisibili morti
della mia tribù. Loro amano questa terra come un neonato ama il battito
del cuore della madre. L'uomo bianco non sarà mai solo. Fate che sia
giusto e gentile nel trattare la mia gente, perché i morti non sono
privi di potere. Morti ho detto? La morte non esiste. Solo un
cambiamento di mondi. Così, se comprerete la nostra terra, amatela come
l'abbiamo amata noi, curatela come l'abbiamo curata noi. Conservate
dentro di voi la memoria di com’era quando l’avete presa in
consegna. E con tutta la vostra forza, con tutta la vostra mente e con
tutto il vostro cuore preservatela per i vostri figli e amatela come dio
ama tutti.

Eaux,
roseaux.
On dirait qu’un de ces mots
se mire dans l’autre.
Joseph Joubert

Ciò
che è pubblico non ha nessun bisogno di essere letto. Tanto per incominciare,
l’autore potrebbe limitarsi a non firmare l’opera. Noli me legere, si prega
di non guardare Euridice. Appello cortese, avvertimento insolito, divieto già
da tempo trasgredito. L’incantatore ha bisogno di assicurarsi che ci sia una
bellezza che lo segue.

Non
passeggiano sugli intervalli, li saltano.

Chi
converte l’aculeo in fiore arrotonda il lampo.
René
Char

Un pittore aveva
ricevuto dall’imperatore l’incarico di disegnare un drago sul
paravento della stanza del trono. Passato qualche anno, l’imperatore si
recò nello studio del pittore per appurare le ragioni del ritardo. Il
posto era pieno di disegni e schizzi di draghi, uno più bello e
particolareggiato dell’altro. L’artista disse che stava facendo degli
studi, ma che presto sarebbe venuto a palazzo per l’opera definitiva.
Poco tempo dopo arrivò e, variando con la punta del pennello la pressione
sulla superficie da dipingere, completò in un attimo il suo lavoro. Da
allora un drago adorna il paravento dell’imperatore nella stanza del
trono.
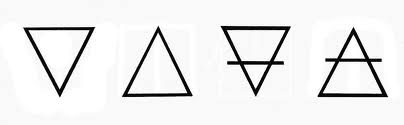
Canta
il merlo e fa un bel verso, chi me lo renderà
questo tempo perso, canta
il merlo bel verso fa, questo tempo perso chi me lo renderà?

Il
a commencé vingt ouvrages sans en avancer aucun, il en est de meme de
ses lectures. Jamais il n’achève un livre.
 
Con la
sagoma di un aquilone misureremo la circonferenza dei fulmini, con un
disco di carta ripeteremo la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Prossimamente su questi schermi la compagnia dei trovatori completerà la
riverenza, le splendide città torneranno a dividersi, gli scolari più
previdenti riporteranno in esilio il mistero delle tavole sempre
imbandite.

Se
tu fossi un poeta, vedresti chiaramente che su questo foglio di carta
scorre una nuvola. Senza la nuvola non può esserci la pioggia; senza
la pioggia gli alberi non crescono; e senza gli alberi non possiamo
fare la carta. La nuvola è essenziale perché la carta esista. Se non
c’è la nuvola, non può esserci neppure questo foglio di carta.
Dunque possiamo dire che la nuvola e la carta inter-esistono.
“Inter-esistere” è una parola che non c’è ancora nel
dizionario, ma se combiniamo il prefisso “inter” con il verbo
“esistere” otteniamo un nuovo verbo, “inter-esistere” appunto.
Senza la nuvola non avremmo la carta, dunque possiamo dire che la
nuvola e la carta “inter-esistono”. Se poi guardassimo più
attentamente questo foglio di carta, potremmo scorgervi la luce del
sole. Senza la luce del sole la foresta non potrebbe crescere. Niente
in effetti potrebbe crescere. Nemmeno noi potremmo crescere senza la
luce del sole. Così sappiamo che su questo foglio di carta c’è
anche il sole. Carta e sole inter-esistono. E se continuassimo
a guardare, vedremmo il taglialegna che ha tagliato l’albero e
l’ha portato alla cartiera perché fosse trasformato in carta. E
vedremmo il grano. Noi sappiamo che il taglialegna non può vivere
senza il suo pane quotidiano, e perciò sul foglio
di carta c’è anche il grano con cui è stato fatto il pane. E ci
sono il padre e la madre del taglialegna. Se guardiamo in questo modo,
capiamo che senza tutte queste cose il nostro foglio di carta non
potrebbe esistere. Guardando ancora più attentamente, vedremmo che ci
siamo anche noi. Non è difficile da comprendere: quando guardiamo un
foglio di carta, il foglio è parte della nostra percezione. La tua
mente è là dentro, come anche la mia. Dunque possiamo dire che su
questo foglio di carta c’è tutto. Non riuscirai a indicare una sola
cosa che non ci sia: il tempo, lo spazio, la terra, la pioggia, i
minerali del sottosuolo, la luce del sole, la nuvola, il fiume, il
calore. Tutto coesiste con questo foglio di carta. Ecco perché penso
che la parola “inter-esistere” dovrebbe essere inclusa nei
dizionari. “Esistere” significa “inter-esistere”. Non puoi
esistere da solo, separatamente. Devi inter-esistere con tutte le
altre cose. Questo foglio di carta esiste perché tutte le altre cose
esistono.
Thich
Nhat Hanh

|

|
Bach e
Beethoven hanno legato la terra con il cielo per impedire a Mozart di
volare via.









La creazione di un piccolo fiore è lavoro di ere.
William
Blake

Urano
non permetteva ai suoi figli di venire alla luce, li nascondeva nel ventre
di Gea, Crono invece li ingoiava appena nascevano.
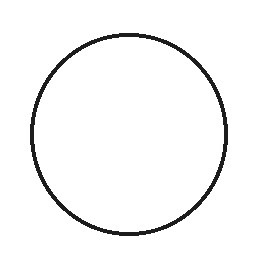
E’ ritrovata.
Che? – L’eternità.
E’ il mare andato
con il sole.
Anima mia sentinella,
mormoriamo l’assenso
della notte sì nulla
e del giorno di fuoco.
Dagli umani suffragi,
dagli slanci comuni,
là ti disciogli
e libera voli.
Da voi soli invero,
tizzoni di raso,
si esala il dovere,
e non si dice: finalmente.
Là, niente speranza,
nessun orietur.
Scienza e pazienza
supplizio sicuro.
E’ ritrovata.
Che? – L’eternità.
E’ il mare andato
con il sole.
Arthur
Rimbaud

Sono
venuto a consacrare. Non importa dove, non importa quando.

Un uomo morto, almeno così pare,
è disteso, abbattuto davanti un enorme animale immobile, minaccioso.
Quest’animale è un bisonte, e la sua minacciosità è tanto più incombente
perché sta morendo: è ferito e, sotto il ventre aperto, si liberano i suoi
intestini. Apparentemente è quest’uomo disteso che colpì con il suo
giavellotto l’animale morente... Ma l’uomo non è un uomo, la sua testa,
quella di un uccello, termina con un becco. Niente di questo complesso di
immagini giustifica il fatto paradossale che l’uomo abbia il sesso eretto.
Georges Bataille

In giro con un’ombra tutta mia.

Come
si chiama la tua terra
dietro il monte, dietro l’anno?
Lo so come si chiama.
Come la fiaba d’inverno, così si chiama,
si chiama come la fiaba d’estate,
La terra dei tre anni di tua madre, era questa,
è questa,
peregrina per ogni dove, come la lingua,
gettala via, gettala via,
così la riavrai.
Paul Celan

Il fuoco, se non vuoi che si
spenga, devi accarezzarlo, sfiorarlo appena, alimentarlo quel tanto che basta
a farne nebbia. Solo così, stretto tra la soglia e l’ombra, quel mormorio
di braci, anche dopo averti scaldato, seguiterà ad incantarti.

Di fianco al borgo bivaccano campi
di mimose. Al tempo del raccolto può starci l’incontro odoroso con le
braccia di una ragazza impiegata tutto il giorno tra quelle rame. Non molto
diversa dal chiarore di una lampada al profumo d’aureola, lei si gira e
subito volta le spalle al crepuscolo. Anche una sola parola sarebbe
sacrilegio. Al piede che smuove l’erba, cedere il passo. Ti sarà forse dato
di staccare da quelle labbra la chimera dell’umidità della notte?
René Char
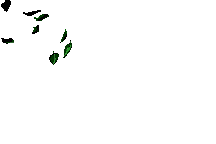
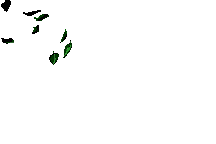
Sereno
e spensierato, come soltanto un genuino nullatenente può essere, un ragazzo
dall’aria bonaria e scioccherella, andava a spasso, un giorno, per la
campagna sorridente e rigogliosa. Lasciandosi alle spalle alberi, cespugli,
cortili e casolari, attraversava leggero, divertito, gaio e scanzonato campi
e foreste, e il buonumore che spirava dal suo volto gli procurava il
cordiale saluto di tutti coloro che incontrava, cosa che del resto non
poteva fargli che piacere. Ma era altresì un tipo animato dalle migliori
attenzioni verso tutte le creature, fossero uomini o animali, e ben disposto
verso tutto il mondo che lo circondava, e quelle persone che sanno vedere
subito, da lontano, come stanno le cose potevano certo accorgersene.
Composto e dignitoso, tributava ognuno dei suoi buonasera, poiché già la
sera – questa bella, nobile fanciulla dagli occhi e dalle mani d’oro –
si andava insinuando tra le piante e i casolari, e vicino e lontano si
levavano rintocchi di campana. Stava passando davanti a un prato, quando un
vitellino allungò il capo nella sua direzione e gli fece capire che avrebbe
desiderato aver qualcosa da lui. O forse voleva farci amicizia, scambiarci
quattro chiacchiere, raccontargli un po’ della sua esistenza di vitellino.
“Non ho nulla, caro animale. Volentieri ti darei in dono qualcosa, se
l’avessi” disse il giovanotto e proseguì, ma andando avanti non
riusciva a togliersi dalla testa quel vitellino che avrebbe desiderato aver
qualcosa da lui.
Un po’ più tardi passò davanti a una splendida casa colonica
situata al limitare del bosco. Ed ecco avventarglisi contro un cane enorme
che abbaiava in maniera assordante, tanto che il buon giovane fu assalito
dal terrore. Ma non c’era nulla da temere. La bestia prese a zompargli
intorno, ma senza il minimo intento aggressivo, anzi affettuosamente; tutto
quell’abbaiare non era stato che l’annuncio esplicito della sua gioia e
non sarebbe stato necessario, da parte della buona villica, di richiamarlo
da lontano a non accogliere la gente in maniera così sconveniente. “Cosa
cerchi da me, buon animale? Vedo bene che desideri aver qualcosa da me, ma
disgraziatamente non ho nulla. Ti darei volentieri qualcosa, se
l’avessi” disse il giovanotto, e il cagnone volle accompagnarlo verso il
bosco di faggi, come per stringere amicizia con lui e narrargli delle sue
vicende di animale. Come vide che l’amico procedeva imperterrito nel suo
cammino, il cane si arrestò per far ritorno alla casa colonica e ai suoi
doveri, mentre il giovane continuò la sua passeggiata; ma strada facendo
non riusciva a togliersi dalla testa quel cane, che gli si era avvicinato
con tanta fiducia e che certamente avrebbe desiderato aver qualcosa da lui.
Passato un buon tratto, dopo essere disceso giù a valle, il ragazzo
s’imbatté, sulla bella e larga strada maestra, in una capra che, non
appena lo vide, gli si avvicinò e prese a seguirlo come fosse un essere
bisognoso di comprensione o volesse confidargli chissà che cosa sulla sua
misera esistenza di capra. “Tu desideri aver qualcosa da me, ma non ho
nulla. Ti darei volentieri qualcosa, caro animale, se l’avessi” le si
rivolse carico di compassione e tirò avanti, ma proseguendo non riusciva a
togliersi dalla testa quegli animali che avrebbero voluto aver qualcosa da
lui – la capra, il cane, il vitellino – che avrebbero voluto stringere
amicizia con lui e volentieri gli avrebbero narrato della loro muta,
paziente, ottusa esistenza, che non conoscono una lingua e non possono
parlare, che vengono al mondo prigionieri e asserviti all’utilità degli
uomini, che gli volevano bene come lui ne voleva loro, che avrebbe più che
volentieri preso con sé e che forse, a loro volta, volentieri lo avrebbero
accompagnato e che avrebbe tanto desiderato aiutare a evadere
dall’angusto, misero regno degli animali per conquistare un’esistenza più
libera e felice. “Ma io non sono nulla, non posso nulla, non possiedo
disgraziatamente nulla, e nell’immensità del mondo non sono che un uomo
povero debole e impotente” concluse, e in quella gli balzò agli occhi la
bellezza del mondo e rivide quegli animali; vide quanto tutti i suoi amici,
uomini e animali, siano abbandonati alla loro sorte, e non poté più
proseguire. Si accomodò sul prato, non lontano dalla strada, e pianse
amaramente la sua stupida esistenza di sbarbatello.
Robert Walser

Trentatré
lumache andavano al mare
per un fosso tutto pieno di guazza
tra
prugne azzurre e raggi di rame
la
testa persa in una nuvola bassa.

Ho
aperto la finestra
e goccia a goccia
ho versato la luna
nel mio boccale di vetro.
Ho
allungato una mano
e con un po’ di timore
mi sono mangiato tutte le stelle
che pascolavano in cielo.
Ho
fatto poi un bel rutto
e
dato che sono un gentiluomo
mi sono pulito la bocca
con
una nuvoletta bianca.

Gira, trottola,
gira.
Gira dalla sera
alla mattina.
La terra sotto le case e la nebbia nel cielo.
Gira, trottola, gira.
Gira tutta la sera e la mattina.

Uno
sciame d’effimere s’imbatté volando in una fortezza, si posò sui
bastioni, prese d’assalto il mastio, invase il cammino di ronda ed i
torrioni. Le nervature delle ali trasparenti si libravano tra le muraglie di
pietra.
“Invano v’affannate a tendere le vostre membra filiformi”, disse la
fortezza. “Solo chi è fatto per durare può pretendere d’essere. Io
duro, dunque sono; voi no”.
“Noi abitiamo lo spazio dell’aria, scandiamo il tempo con il vibrare
delle ali. Cos’altro vuol dire: essere?”, risposero quelle fragili
creature. “Tu piuttosto, sei soltanto una forma messa lì a segnare i
limiti dello spazio e del tempo in cui noi siamo”.
“Il tempo su di me scorre: io resto”, insisteva la fortezza. “Voi
sfiorate soltanto la superficie del divenire come il pelo dell’acqua dei
ruscelli”.
E le effimere: “Noi guizziamo nel vuoto così come la scrittura sul foglio
bianco e le note del flauto nel silenzio. Senza di noi, non resta che il
vuoto onnipotente e onnipresente, così pesante che schiaccia il mondo, il
vuoto il cui potere annientatore si riveste di fortezze compatte, il
vuoto-pieno che può essere dissolto solo da ciò che è leggero e rapido e
sottile”.
Italo
Calvino

Ecate
trimorfa, figlia di Fanes, protettrice
delle strade, regina celeste, terrestre e marina, luna piena, luna
crescente, luna calante, seme, spiga e fungo, trivia, amabile, senza
cintura, candida mente, signora delle solitudini e degli almanacchi,
custode di tutto il cosmo.

Ridono
e nascono
nel va e
vieni del mondo
tanti mondi profondi
che nuovamente vagano
e fuggendo, attraverso gli altri,
sembrano ogni volta più belli.
Si concedono nel passare,
s’ingrandiscono nel fuggire,
svanire è la loro vita.
Non sono più preoccupato
poiché posso,integro, attraversare
il mondo come mondo.
Robert
Walser |

Partecipare
allo slancio. Non al festino, suo epilogo.
René Char
     
Un
giorno, davanti al tempio di Afrodite a Pafo, Smirna, figlia di re Cinira
di Cipro, si vantò di avere capelli più belli di quelli della dea
dell’amore. La cosa non dovette garbare molto ad Afrodite che, per
vendicarsi, la gettò tra le braccia del padre. Per dodici giorni e dodici
notti, infatti, o almeno così dice la storia, i due furono amanti.
Qualche tempo dopo, re Cinira si scoprì padre e nonno del bimbo che
Smirna portava in grembo e, pazzo di rabbia, la inseguì per tutta la città.
Non sapendo dove nascondersi, la ragazza chiese agli dèi di non essere in
nessun luogo, né tra i vivi e né tra i morti. Preghiera prontamente
esaudita, e destino vuole che fosse proprio Afrodite a salvare la
fanciulla dalla furia omicida del genitore, trasformandola in un albero di
mirra. Subito dopo il parto, la dea chiuse Adone (questo è il nome del
bambino) in un baule e lo affidò a Persefone, regina dei morti, perché
lo custodisse in un posto sicuro. Mossa dalla curiosità, Persefone aprì
il baule e vi trovò dentro Adone. Il fanciullo era così bello che la
regina dell’Ade decise di portarlo nel suo palazzo al centro della
terra. Afrodite, informata della cosa, scese subito nel Tartaro per
riprendersi il maltolto. E quando Persefone non volle restituirlo, perché
ne aveva già fatto il suo amante, Afrodite si appellò al giudizio di
Zeus. Il signore dell’Olimpo, consapevole che anche la dea dell’amore
era smaniosa di andare a letto con Adone, rimise la contesa al tribunale
presieduto dalla musa Calliope. Il verdetto di Calliope stabilì che
Afrodite e Persefone avevano uguali diritti su Adone, perché una lo aveva
salvato al momento della nascita, e l’altra aveva fatto la stessa cosa
poco tempo dopo, aprendo il baule. Per proteggere il fanciullo dalle brame
delle due insaziabili dee, era necessario concedergli un periodo di
riposo. Calliope divise così l’anno in tre parti uguali: nella prima
Adone sarebbe stato con Persefone, nella seconda avrebbe frequentato
Afrodite, e nella terza sarebbe rimasto da solo. Ma Afrodite non si
comportò lealmente e, disubbidendo agli ordini di Calliope, costrinse il
fanciullo a trascorrere quasi tutto il tempo in sua compagnia.
Ferita nell’orgoglio, Persefone si recò in Tracia e disse ad
Ares, signore della guerra, che oramai Afrodite gli preferiva Adone. Preso
dalla gelosia, il dio si trasformò in un cinghiale, inseguì il ragazzo
per tutto il monte Libano e, davanti agli occhi atterriti di Afrodite, lo
azzannò a morte. Anemoni sbocciarono dal sangue di Adone e la sua anima
discese al Tartaro. Poco dopo Afrodite si recò da Zeus e chiese che fosse
concesso ad Adone di trascorrere soltanto la metà più cupa dell’anno
in compagnia di Persefone e tutto il resto della stagione chiara di nuovo
in sua compagnia. Il signore degli dèi acconsentì. Da allora Adone è lo
spirito della vegetazione, il simbolo della natura che muore e rinasce
continuamente. Ancora oggi, infatti, nelle feste in suo onore si rievocano
il congiungimento e la separazione: un giorno si celebrano le nozze e il
giorno dopo il suo funerale. Adone giace per terra, Afrodite lo ama, lo
piange, inutilmente cerca di trattenerlo, poi, con il passare delle ore,
lentamente egli si dilegua tra le onde e nell’aria. Ma Adone è vivo,
Adone tornerà sempre come le rondini. Per questo le donne tagliano i loro
capelli, giacciono con gli stranieri nel tempio, confezionano quelli che
vengono chiamati i Giardini di Adone. Trattasi di cestini pieni di terra
che, per dodici giorni, vengono riempiti con semi di frumento, orzo,
lattuga, finocchio e vari tipi di fiori. Con il calore del sole, le
piantine germogliano rapidamente ma, non avendo radici, altrettanto
rapidamente appassiscono. E allo scadere dei dodici giorni, quei piccoli
recipienti vengono portati via con le effigi di Adone e gettati in mare o
nelle sorgenti. Questo sortilegio serve a favorire la crescita della
vegetazione, perché Adone da sempre ne impersona il ruolo, da sempre ne
è il signore. Il contadino deve propiziarsi lo spirito del grano che lo
nutre, così come il pastore deve placare lo spirito delle erbe e delle
foglie che il suo gregge rumina, e il raccoglitore deve fare altrettanto
con le radici che estrae dalla terra e i frutti che coglie dal ramo.
Simili ad Adone sono Attis nell’Asia Occidentale, Osiride in Egitto, per
non parlare delle affinità con Dioniso e con la morte e resurrezione di
Gesù Cristo.

Altissimu,
onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria et
l’honore et omne benedictione.
Ad
te solo, altissimo, se konfano,
et nullu homo éne dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo
qual’è jorno, et allumini noi per lui.
Et
ellu è bellu et radiante cum grande splendore:
da te, Altissimo, porta significatione.
Laudato
si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate
clarite et preziose et belle.
Laudato
sì, mì Signore, per frate Vento
et per
aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato
sì, mì Signore, per sor’aqua,
la quale è molto utile et umile et preziosa et casta.
Laudato
sì, mì Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
et ello è bello et
iocundo et robustoso et forte.
Laudato
sì, mì Signore, per sora nostra madre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi cum
coloriti flori et herba.
Laudato
sì, mì Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et
tribulatione.
Beati
quelli ke ’l sosterranno in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato
si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
Guai a cqelli che morranno ne le peccata mortali;
Beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ’l farrà male.
Laudate
e benedicete mi’ Signore et rengratiate
et serviateli cum grande humiltate.
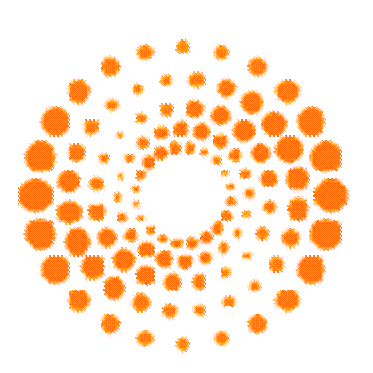
guardo gli
asini
che volano nel ciel
ma le papere sulle nuvole
si divertono
a fare i cigni nel ruscel
bianco come inchiostro
vanno i treni
sopra il mare tutto blu
e le gondole bianche
sbocciano nel crepuscolo
sulle canne di bambu'
du du du du du
queste strane cose
vedo ed altro ancor
quando ticchete ticche
ticchete ticche
ticchete sento che è
guarito il cuor
dall'estasi d'amor
Stan
Laurel & Oliver Hardy

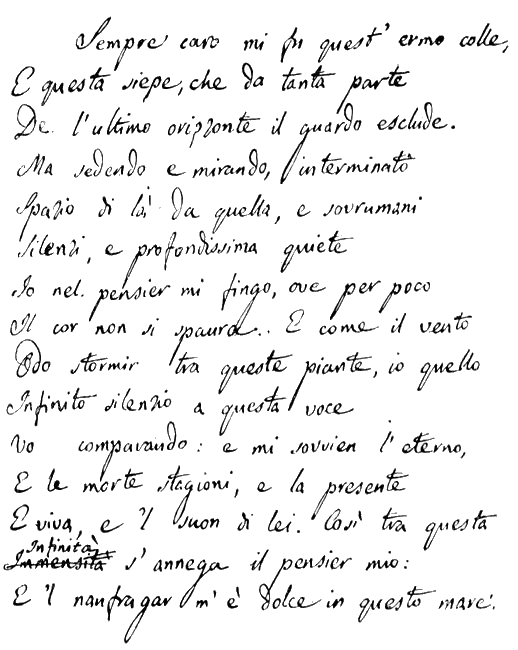

goo
goo johnny goo goo
go
johnny go go go johnny go
go
go johnny go go
johnny
b goode

Il
Mazapegul è un folletto dispettoso, il protettore delle bestie e della
casa. Con il suo bastone da passeggio e con in testa un berrettino rosso,
il Mazapegul è l’antico spirito che giace con le donne. Di gradevole
aspetto, lo si direbbe un incrocio tra un gatto e uno scimmiotto. Come la
maggior parte dei suoi simili, non gira che di notte e lascia impronte
dappertutto. Se lo tratti bene, ti fa i lavori domestici, ma se lo fai
arrabbiare, ti rovescia tutta la casa. Il Mazapegul lo puoi scacciare in
centomila modi. Lo puoi anche catturare, chiudendolo in un sacco. Ma a che
pro? La notte dopo lo troveresti ancora lì, leggero come un refolo di
vento e pesante come la pietra degli incubi. Per il dizionario Devoto-Oli,
il folletto è un “essere fiabesco della tradizione popolare, piccolo ed
astuto, magnificamente operante a danno o a vantaggio dell’uomo”.
Folletto, in romagnolo fulèt, nodo di vento, piccolo mulinello che
s’alza quando l’aria è calma. La radice “fol” significa “soffio
d’aria” da cui derivano i termini latini follis, flare, flatus, e gli
italiani folle, folata, folletto, ma anche fola, favola. Il Mazapegul è
piccolino, di pelo grigio e corre spedito sulle zampette posteriori. In
testa porta un berretto rosso e tra le mani stringe un bastone da
passeggio. Per il resto è nudo come un verme o un bambino appena nato. Il
Mazapegul è il genio tutelare della famiglia, lo spirito degli antenati,
è quell’attività onirica che mette in comunicazione il cielo con la
terra. Per Anselmo Calvetti, Mazapegul è derivato da pécul/pécol e
significa “il piccolo dalla mazza”. La mazza (bastone, martello, zanèta)
intesa come l’arma con la quale la divinità tutelare della casa
impediva agli spiriti maligni di oltrepassare la soglia domestica. Il
Mazapegul alza le sottane delle signore, salta in groppa alle rane,
intreccia le code delle mucche, le criniere dei cavalli, i capelli delle
fanciulle, nasconde e sposta oggetti, suggerisce sogni, dona gioia e
spensieratezza alle persone amate. Il Mazapegul può trasformarsi in un
filo d’erba, una foglia, un sasso, può essere così piccolo da passare
per il buco della serratura o così grande da bloccare una strada.
Inconsistente come l’aria, il Mazapegul è capace di assumere qualsiasi
aspetto, può diventare un animale, un attrezzo da lavoro, un gomitolo di
lana, una fiammella, un mostro, oppure può trasformarsi in radici,
tronchi, rami. Il Mazapegul fa i dispetti a quelli che lavorano, sa
imitare la voce umana, si diverte a confondere i discorsi, eccetera,
eccetera.

Naturalmente
l’anima canta il bello, e non sempre nella misura del verso, ma con
personali e reciproche armonie di forma, colore e sentimento. Quando
questo avviene, è bello ascoltare e, malgrado l’autore, tutto
s’accorda e torna a risuonare. Non resta allora che un tira e molla di
corde, e anche chi scrive prende a girare come uno strumento sapientemente
organizzato.

Gli
ottimi scrittori scrivono poco perché hanno bisogno di molto tempo per
ridurre in bellezza la loro abbondanza e la loro ricchezza.
Joseph Joubert


I
fossi sono posti sacri, musica sapiente, il regno delle nubi e della
nebbia. Qui vivono i trovatori, i trasparenti, gli angeli confusi. I fossi
sono cattedrali, anellini nuziali, un imbuto aromatico pieno di tepori e
di stelle, l’arcipelago dove le piccole creature selvatiche si divertono
a moltiplicare i mondi. E’ nei fossi che i bambini si appostavano con le
candele e le zucche, ed è nei fossi che si consumavano gli amori più
audaci e le burle più feroci, ed è ancora nei fossi che finivano tutti
quelli che andavano troppo forte. La rosa è bella, il grano riempie la
pancia, la vite scalda il cervello, ma la malerba non serve proprio a
niente, è soltanto vapore, polvere da sparo, un liquore tiepido e che fa
sognare. Per uno spuntino alla Rimbaud, la malerba si accompagna
perfettamente con quel pane che, per essere buono, deve cuocere sulla mano
del fornaio.





Se
Adone è lo spirito vegetale che muore e rinasce, Demetra e Persefone sono
la crescita e la fruttificazione del chicco di grano. Il mito di Demetra e
Persefone celebra la fine del nomadismo e la nascita dell’agricoltura,
racconta il viaggio di un seme che lascia la terra per donare un corpo
alla morte e un’anima al mondo. Il mito di Demetra e Persefone è anche
la più straordinaria esperienza psichedelica che la nostra umanità abbia
conosciuto. Tutto ebbe inizio quando Ades, fratello di Zeus e Poseidone,
rapì sua nipote Core-La fanciulla, figlia di Demetra, mentre, in
compagnia delle Oceanine, raccoglieva fiori nel giardino di Ecate. Ades
portò Core nel suo regno e, con il nome di Persefone, essa divenne sua
sposa. Per giorni e giorni, disperatamente, questo dice il prosieguo della
storia, Demetra cercò la figlia scomparsa. Quando finalmente venne a
sapere che Persefone, con il consenso di Zeus, era stata rapita da Ades,
s’infuriò con il signore dell’Olimpo e decise di non vivere più con
gli dèi, ma di andare tra gli uomini sulla terra. Qui vagò senza meta,
prima di giungere, camuffata da mortale, ad Eleusi, dove venne
cordialmente ospitata e impiegata come nutrice a palazzo. In seguito, dopo
aver svelato la sua natura divina, Demetra fece erigere un tempio e diede
istruzioni per il culto. Terminate le opere, sempre più decisa a sfidare
l’olimpo, la dea cercò prima di negare la morte, offrendo a tutti
l’eternità, poi tentò di farla diventare eterna, scatenando una
terribile siccità che, per un anno intero, impedì ai semi di
germogliare, lasciandoli sepolti nel sottosuolo. A questo punto,
paventando il rischio di perdere le offerte degli umani, il gran consesso
degli dèi chiese a Zeus di intervenire. E molto saggiamente il Cronide
pose fine all’incresciosa vicenda. Ad Ades non rimase che ubbidire, non
prima però di aver fatto mangiare a Persefone un chicco di melograno,
unico frutto capace di farla rimanere regina degli inferi, pur
trascorrendo la parte più dolce dell’anno in compagnia della madre.
Prima di far ritorno all’Olimpo, Demetra rivelò i suoi misteri e insegnò
agli uomini la coltivazione del grano. “Felice colui, tra gli uomini
viventi sulla terra, che ha visto queste cose! Chi invece non è stato
iniziato ai sacri misteri, chi non ha avuto questa sorte, giammai avrà
simile destino, nemmeno dopo la morte, laggiù, nella squallida
tenebra”. Così recita lo splendido inno Omerico. I misteri in questione
sono quelli di Eleusi, molto probabilmente i più importanti
dell’antichità, misteri che, per circa duemila anni (dal 1500 a.c. al
IV secolo d.c.), furono celebrati in Grecia, nei dintorni di Atene, in
onore di Demetra e di sua figlia Persefone.

O
Dio, concedici il meglio delle benedizioni, una mente per pensare e un
amore sorridente, maggiori ricchezze, un corpo sano, linguaggio amabile e
giorni festosi.
Rg-veda

|
Quando
nell’impasto dell’aria trema
all’improvviso
accorato il cardellino,
la cattiveria pepa la sua piccola toga
e è bellissima nera la cuffietta.
Calunniano
il posatoio e l’assicella,
calunnia la gabbia coi suoi cento aghi
e tutto il mondo è alla rovescia
e c’è una Salamanca boscosa
per i saggi uccellini disobbedienti.
Osip Mandel’stam |


traducendo
dio

le nuvole stanno pigre e larghe
nel cielo come gatti distesi
Robert Walser
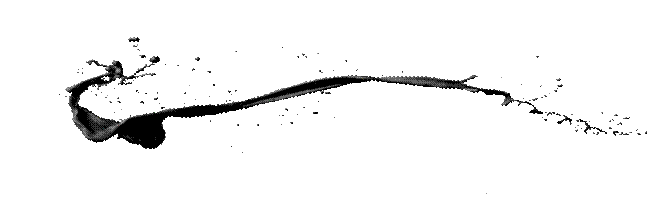
Le cose esistono in se stesse.
Lassù sopra la luna
intravedo la lepre
in un vaso
che pesta il riso per le focacce.
Ne chiedo una.
“Di che forma?” dice la lepre.
“Una simile a un razzo”.
“Ecco –prendi!”.
Sopra, fuori,
ogni cosa passa
d’un colpo,
libero finalmente
ignaro
di dove sto andando.
Shinkichi Takahashi
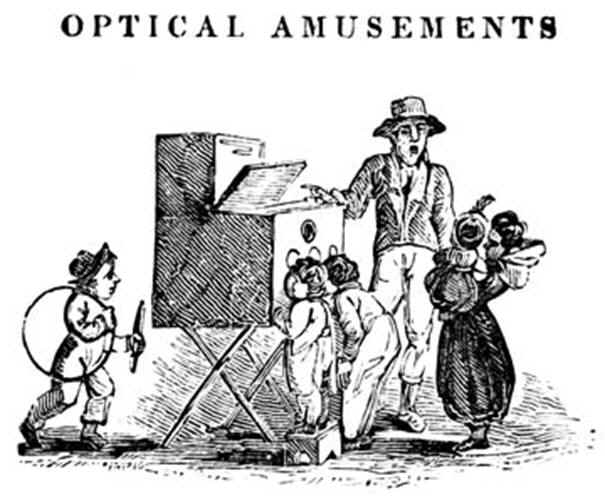
Un
lavoro di punta.
René Char

Lumaca
lumachina, vieni qui sulla mia manina, non andare da quel birbone che ti
mette sul carbone, il carbone brucerà, la lumaca canterà.

Il
musicista è forse il più modesto degli animali, ma anche il più fiero.
E’ lui che ha inventato l’arte sublime di sciupare la poesia.
Erik Satie
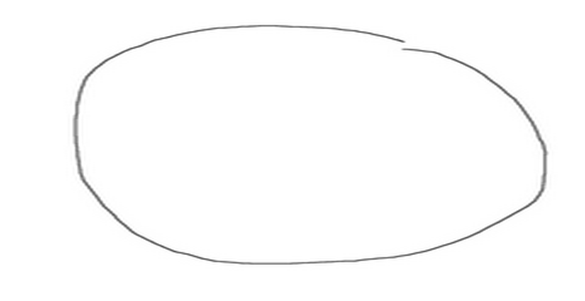
Questa è la storia di un suonatore
che andò a suonare all’inferno, un posto dove non succede mai niente e
che si trova proprio dietro l’uscio di casa.
Si parte con uno scambio di battute tra il protagonista e la madre:
“Fatemi da mangiare, presto, che devo andare a suonare!”, dice il
ragazzo.
“Non sarai mica matto? Oggi è venerdì e il venerdì non si suona!”,
risponde la madre.
“Io sono un suonatore e i suonatori suonano quando c’è da suonare”,
continua il ragazzo.
“Andassi a suonare all’inferno!”, conclude la madre.
Giusto il tempo di tirarsi dietro l’uscio di casa, e il protagonista di
questa storia sente una folata e la voce di uno che dice:
“Giovanotto, si va a suonare, eh?”.
Ed ecco la risposta:
“Io sono un suonatore e suonare è quel che i suonatori fanno.
La voce poi aggiunge:
“Stasera il posto è lontano, ma se vuole accomodarsi sui miei piedi, ci
mettiamo un attimo ad arrivare”.
Il suonatore accetta, e adesso siamo in una sala rossa, rotonda e piena di
gente; e mentre il nostro amico sta per attaccare la canzone del
Barabano, arriva un morto che così lo saluta:
“Sei morto anche tu, suonatore? Ma lo sai dove ti trovi? Siamo
all’inferno!”.
Il ragazzo non capisce:
“All’inferno? Ma sei sicuro? E
adesso come faccio a tornare indietro?”.
Il morto trova la soluzione:
“Li vedi quei tre mucchi laggiù? Sono tre sacchi pieni di soldi; quando
il diavolo ti chiede quale vuoi, tu non scegliere i due grandi ai lati, ma
quello piccolo in mezzo; se no, resti qui per sempre”.
La storia finisce con il suonatore che racconta alla madre la sua
avventura in quel posto dove non succede mai niente.



Paul Celan

Poesie di uno che percepisce e osserva, di uno che volge la sua
attenzione a quanto appare, lo interroga e gli parla: esse sono dialogo.
Entro lo spazio di questo dialogo si costituisce il soggetto cui è
rivolto il discorso, esso si rende presente, si raggruma intorno all’io
che gli rivolge la parola e lo nomina. Ma, in questa presenza, ciò che
attraverso la nominazione e l’interlocuzione è diventato praticamente
un tu introduce la propria alterità ed estraneità.

Fenomeno sublunare, terrestre e
creaturale. Linguaggio attualizzato, sonoro e sordo a un tempo.

E cerco anche, perché mi ritrovo
dove ho cominciato, il luogo della mia origine.
Con dito impreciso lo cerco sulla carta geografica. Questo luogo è
introvabile, non esiste; ma io so dove dovrebbe essere, e qualcosa trovo.
Trovo quello che unisce, quello che può avviare il poema all’incontro.
Trovo qualcosa che è immateriale, eppure è terrestre, planetario,
qualcosa di circolare che ritorna a se stesso attraverso entrambi i poli.

Sempre e soltanto un io che parla dal particolare angolo d’incidenza
della propria vita e ricerca una delimitazione, un orientamento.
 Paul
Celan
Paul
Celan


Aveva conosciuto giorni migliori,
nonostante la sua miseria e la sua infermità.
A quindici anni una vettura gli aveva schiacciato tutte e due le gambe
sulla strada maestra di Varville. Da allora mendicava trascinandosi lungo
le strade, nei cortili delle fattorie, dondolandosi sulle stampelle che
gli avevano sollevato le spalle sin quasi alle orecchie. Il suo capo
pareva sprofondato tra due montagne.
Trovatello scoperto in un fosso dal curato di Billettes, la vigilia del
giorno dei Morti, era stato battezzato da lui col nome di Nicola
Ognissanti. Allevato per carità, privo di qualsiasi istruzione, divenuto
storpio per aver bevuto qualche bicchierino di acquavite datogli per gioco
dal fornaio del paese, e da allora, vagabondo, non sapeva far altro che
stendere la mano.
Un tempo la baronessa di Avary gli aveva concesso un piccolo giaciglio, in
una specie di nicchia vicina al pollaio, nella fattoria annessa al
castello; nei giorni di fame nera era sicuro di trovare sempre in cucina
un tozzo di pane e un bicchierino di sidro. Spesso riceveva anche qualche
soldo che la baronessa gli lanciava dalla scalinata o dalla finestra della
sua camera. Adesso era morta.
Nei villaggi non gli davano più nulla: lo conoscevano troppo; erano stufi
di lui dopo quarant’anni che lo vedevano andare da una casupola
all’altra con il corpo cencioso e deforme su due trampoli di legno. Però
non se ne voleva andare, perché sulla terra non conosceva altro che
quell’angolo di mondo, quei tre o quattro cascinali dove aveva
trascinato la sua miserevole esistenza. Aveva posto confini alla sua
mendicità, e non li avrebbe mai varcati.
Ignorava se il mondo si stendesse oltre quegli alberi che scorgeva in
distanza e chiudevano il suo orizzonte. Non se lo chiedeva nemmeno. E
quando i contadini, stanchi di vederselo sempre tra i piedi, gli
gridavano:
- Perché non vai a seccare la gente degli altri villaggi, invece di
ronzare sempre da queste parti?
Lui non rispondeva e si allontanava, preso da una vaga paura
dell’ignoto, la paura del povero che teme confusamente mille cose, le
facce nuove, le ingiurie, gli sguardi sospettosi delle persone che non lo
conoscevano, i gendarmi che girano sempre in coppia e d’istinto lo
portavano a nascondersi nelle siepi o dietro i mucchi di breccia.
Quando li vedeva da lontano, luccicanti sotto il sole, trovava di colpo
una strana agilità, un’agilità da mostro, per rifugiarsi in un
nascondiglio. Capitombolava giù dalle stampelle, si lasciava cadere come
uno straccio, si rannicchiava, rimpiccioliva, diventava invisibile, si
acciambellava alla maniera delle lepri, mentre confondeva i suoi stracci
scuri con la terra.
Eppure non aveva mai avuto a che fare con loro. Quella paura lui la teneva
nel sangue, quasi fosse un dono dei genitori che non aveva mai
conosciuto.
Era senza un rifugio, un tetto, una capanna, un riparo. D’estate dormiva
dappertutto, e d’inverno si infilava con rara abilità nei fienili o
nelle stalle. Se la svignava sempre prima che si accorgessero della sua
presenza. Conosceva i buchi dai quali penetrare negli edifici e, siccome
il maneggiare le stampelle gli aveva rafforzato le braccia in modo
sorprendente, si arrampicava con la sola forza delle mani fino ai granai,
dove a volte rimaneva quattro o cinque giorni senza muoversi, se nei suoi
giri aveva raccattato cibo a sufficienza.
Viveva in mezzo agli uomini come
una bestia selvatica, senza conoscere nessuno, senza amare nessuno,
suscitando nei contadini solo una specie di disprezzo indifferente e di
ostilità rassegnata. Lo avevano soprannominato “Campana”, perché,
dondolandosi tra l’una e l’altra stampella, a guisa di battaglio,
richiamava alla mente proprio l’immagine di una campana.
Non mangiava da due giorni. Nessuno gli dava più niente. Ormai non ne
volevano più sapere di lui. Le
contadine, di sulle soglie, appena lo vedevano giungere, gli gridavano:
- Vuoi andartene, tanghero? Sono appena tre giorni che ti ho
dato un pezzo di pane!
E lui piroettava sulle stampelle, e se ne andava alla casa accanto, dove
veniva accolto allo stesso modo.
Da una porta all’altra le donne dicevano:
- Non si può mica nutrire quel fannullone tutto l’anno, che diamine!
Il fannullone aveva tuttavia bisogno di mangiare tutti i giorni.
Aveva già percorso Saint-Hilaire, Varville e Billettes, senza raccogliere
un centesimo o una crosticina di pane. La sua sola speranza era Tournolles,
ma doveva fare due leghe sulla strada maestra, e non riusciva più ad
andare avanti dalla stanchezza, con lo stomaco vuoto come le tasche. Si
pose tuttavia in cammino.
Era dicembre, sui campi soffiava un vento freddo, fischiava tra i rami
spogli e le nuvole galoppavano nel cielo basso e tetro, affrettandosi
verso non si sa dove. Lo storpio procedeva lentamente, spostando le
stampelle una dopo l’altra con uno sforzo terribile, appoggiando il peso
sulla gamba storta che gli rimaneva, fasciata all’estremità da un
cencio sudicio.
Ogni tanto si sedeva sul fosso per riposare qualche minuto. La fame
gettava una angoscia disperata nel suo animo torbido e appesantito.
Non aveva che un’idea: ”mangiare”; ma non sapeva come.
Per tre ore penò lungo la strada; poi, quando vide gli alberi del paese,
accelerò i movimenti.
Il primo contadino che incontrò, e al quale chiese l’elemosina, gli
rispose:
- Sei ancora qui, scroccone! Non riusciremo dunque mai a sbarazzarci di
te?
Campana si allontanò, avvilito. Lo respinsero a tutte le porte, senza
dargli nulla; ma lui, paziente e ostinato, continuò il suo giro.
Non raccolse neanche un soldo.
Si spinse allora sino alle fattorie, trascinandosi sulla terra molle di
pioggia, così estenuato che non poteva più alzare le stampelle. Fu
scacciato da tutti. Era uno di quei giorni freddi e tristi in cui i cuori
si stringono, gli spiriti si irritano, l’anima s’abbuia, la mano non
si tende né per dare né per soccorrere.
Quando ebbe visitato tutte le case che conosceva, andò a buttarsi sul
ciglio di un fosso, lungo l’aia di mastro Chiquet. Si sganciò, come
dicevano per indicare il modo in cui si lasciava cadere tra le alte
stampelle facendole scivolare sotto le braccia. E rimase a lungo immobile,
tormentato dalla fame, ma troppo abbrutito per capire la sua insondabile
miseria.
Aspettava non si sa che cosa, con quella vaga attesa che rimane sempre
dentro di noi. Aspettava all’angolo di quell’aia, nel vento gelido,
l’aiuto misterioso che si spera sempre venga dal cielo o dagli uomini,
senza chiederci come, né perché, né da chi potrebbe giungere. Passò un
branco di galline, cercando da mangiare nella terra che tutti nutre. Tutto
il tempo prese a bazzicare, a razzolare, a beccare un granello o un
insetto invisibile.
Campana le guardava senza pensare a niente; poi gli venne, più nel ventre
che nella mente, la sensazione più che l’idea che una di quelle
bestiole sarebbe stata buona da mangiare alla griglia.
Il sospetto che stava per commettere un furto non lo sfiorò nemmeno.
Prese un ciottolo a portata di mano e, siccome era abile, lo scagliò,
uccidendo sul colpo il volatile più vicino a lui. La bestiola cadde su di
un fianco agitando le ali. Le altre fuggirono, dondolando sulle loro
zampette, e Campana, rimontando sulle stampelle, si diresse a raccogliere
la preda con movimenti simili a quelli delle galline.
Mentre stava arrivando vicino al corpicino nero con la testa macchiata di
sangue, ricevette in piena schiena uno spintone che lo fece ruzzolare
dieci passi più avanti. E mastro Chiquet, esasperato, gli si avventò
sopra, lo tempestò di pugni e calci come un forsennato, infierendo sempre
più contro di lui, che era infermo e incapace di difendersi.
I coloni della fattoria accorsero e si unirono a mastro Chiquet nelle
percosse. Quando furono stanchi di percuoterlo, lo sollevarono e lo
rinchiusero nella legnaia; poi fecero chiamare i gendarmi. Campana, mezzo
morto, insanguinato, affamato, rimase steso per terra. Giunse la sera, poi
la notte e poi l’aurora. Non aveva ancora mangiato nulla.
Verso mezzogiorno comparvero i gendarmi e aprirono con cautela la porta
aspettandosi resistenza, perché mastro Chiquet aveva fatto credere di
essere stato aggredito dal mendicante e di essersi difeso a fatica.
Il brigadiere gridò:
- Su, in piedi!
Ma Campana non poteva più muoversi, tentò di sollevarsi sulle stampelle,
senza riuscirvi, e i due gendarmi, credendo ad un’astuzia, ad una
cattiva volontà del malfattore, lo afferrarono e lo misero di forza sulle
stampelle.
Campana fu preso da quel terrore istintivo per le cinture gialle dei due
gendarmi che l’aveva sempre angustiato, quel terrore da cui è colta la
selvaggina dinnanzi al cacciatore, il topo dinnanzi al gatto. Per uno
sforzo sovrumano, riuscì a rimanere ritto.
- Cammina! - ordinò il brigadiere.
Egli si mosse. Tutti i contadini della fattoria lo guardarono partire. Le
donne gli mostravano i pugni; gli uomini sghignazzavano, lo insultavano.
Finalmente lo avevano preso! Finalmente se n’erano sbarazzati!
Si allontanò tra i suoi due custodi. Trovò la disperata energia di
trascinarsi ancora sino a sera, abbrutito, non sapendo più neanche che
cosa gli sarebbe successo, troppo smarrito per capire qualcosa.
La gente,per strada si fermava a guardarlo, e i contadini mormoravano:
- Sarà un ladro!
Giunse sul far della notte al capoluogo del circondario. Non si era mai
spinto fino a lì. Non capiva quello che stava accadendo, né immaginava
quel che sarebbe accaduto. Tutte quelle cose orribili, impreviste, quelle
facce e quelle case nuove lo costernavano.
Non pronunciò una parola, non avendo niente da dire, perché non capiva
più niente. D’altro canto erano tanti anni che non parlava più con
nessuno, aveva quasi perso l’uso della lingua; e i suoi pensieri erano
troppo confusi per tradursi in parole.
Lo rinchiusero nella prigione del paese. I gendarmi non pensarono che
poteva aver bisogno di mangiare, e lo lasciarono lì fino al giorno dopo.
Ma di prima mattina, quando vennero per interrogarlo, lo trovarono morto
per terra.
Che sorpresa!
Guy de Maupassant








La poésie ne rythmera plus l’action; elle sera en avant.
Arthur
Rimbaud

Onorano
la poesia coloro che le ricordano che, a riposo, può parlare di tutto,
persino di “disgrazie e primizie”; inebriarsi di tutto, persino degli
odori di maggiolino, commensale di un proverbio.
René
Char

Ci
sono alberi che ti fanno girare in tondo e alberi che ti fanno sentire a
casa. Terra, aria, acqua e fuoco si ritrovano in un bel palazzo. Posso
farti da guida, portarti avanti e indietro come una stella del rock’n’roll?
Qui puoi trovare quello che ti serve, quello che la benevolenza ha
preparato per te. Vuoi un lombrico, una nuvola, un calendario, uno
strepito, una bussola? Il cortile è grande, e a tre passi dall’ingresso
c’è un giuggiolo. A me sembra un amuleto per uccelli, lo sbuffo di
un’astronave marziana. Sono stati i romani a portarlo qui, i romani e le
strategie oblique dei nostri pronipoti. Originario della Siria, 6-7 metri
d’altezza, aspetto contorto, rami irregolari e spinosi (ogni nodo
presenta una coppia di piccole spine), questo fratello freddoloso è in
realtà l’ombelico della casa e sicuramente anche la nostra più bella
foto di famiglia. “Volta, rivolta e torna a rivoltare”,
cantavano gli Scariolanti. “Con tutti gli esseri e con tutte le cose
noi saremo fratelli”, dicevano i Pellerossa.
Vedi anche tu una vela al posto dei remi, un leone al posto del
cammello, un pianeta al posto della pineta? Noi romagnoli siamo
imparentati con il cachi, e questo è un pensiero che va al di là dei
colori, dei sapori e degli odori. Credo sia devozione. Hai presente l’ave
verum corpus di Mozart o, per meglio dire, la pallina del flipper?
Bene, anche mezza risposta potrebbe essere la prova provata che il sei sta
al nove esattamente come il nove sta al sei, e che la sfrontatezza di
questo paese è in realtà il continente che abbiamo sempre sognato.
Tornando al nostro alberello, temo che i suoi frutti siano esagerati
almeno quanto il resto di questa tiritera. Qualcuno ha mai visto un
romagnolo mangiarli? Io no di certo. Sempre troppo bello da guardare e
troppo buono da indossare, il cachi è una reliquia da tenere sotto una
campana di vetro. Nel ferrarese e dalle parti di Urbino si è fatto
conoscere come candito, noi preferiamo usarlo invece come albero di
Natale. Non è una differenza da poco e forse neanche il pretesto per un
respiro più grande. Niente di meglio di un fico esiste oggi sulla faccia
di Gaia, niente di più glorioso e gentile sta girando nel vento. Nella
Grecia antica questa pianta era legata a Dioniso, nell’India della
Trimurti era invece l’asse del mondo, l’albero cosmico che unisce il
cielo alla terra. Si dice fico, ma a me viene in mente l’azzurro del
cielo, la sensualità dei campi, l’odore dei fulmini e della carta
stampata. Quello che sta nel cortile del palazzo non è molto
convertibile, fruttifica quando pare a lui, e credo si senta in debito
soltanto con la primavera. Pesca, mosca, lisca e fiasca; pesca la lasca
e mettila in tasca. La canzone continua con un bambino che prende un
clarinetto in DO e suona tutte le note. Se c’è una pianta che non
conosce l’ombra, questa è di certo il pioppo. Hai presente le prugne
secche, le castagne, le mele, le carrube e l’uva passa? Noi romagnoli
diciamo pioppo (per essere più precisi, “piopa”, al femminile), ma
dovremmo aggiungere anche “Segavecia”, la bella strega da tagliare e
da bruciare alla fine dell’inverno. Quello del pioppo è un reame grande
abbastanza per la beccata di un passero, ma ancora troppo piccolo per il
gioco della ricreazione. Saresti imbarazzato se adesso strappassi un po’
di bianco e un po’ di nero dalle sue foglie? Niente sopra di noi e
niente sotto di noi, soltanto un cielo a righe da portare in tasca. Fine
dell’intervallo e inizio delle indulgenze. Uno, due, tre, quattro,
cinque, sei e sette. Amore è una parola di cinque lettere, proprio
come morte, vita ne ha invece quattro, tre meno di libertà, sette
meno di compassione. Ci sono alberi che ti fanno girare in tondo e
alberi che ti fanno sentire a casa, l’albero dei saluti è piantato tra
due acque, il cerchio che racchiude e la circonferenza che tutto scioglie.
Vogliamo prendere qualche misura, circoscrivere la sua sfera, garantire
ancora il transito delle stagioni?

La Flagellazione di Piero
della Francesca (Tempera su tavola di 59 x 81,5 cm) si divide in due aree
rettangolari. A sinistra c’è la scena che titola il quadro, mentre a
destra un uomo è affiancato da due signori che lo ignorano
completamente.
Le due scene sono disgiunte, anche temporalmente. Quella della
flagellazione è facilmente riconoscibile, ma si svolge in secondo piano
sulla parte sinistra del quadro. I tre uomini in primo piano sulla destra
volgono invece le spalle a Cristo e ai suoi carnefici.
A sinistra c’è un uomo seduto, è vestito come un imperatore orientale,
tiene le mani in grembo e il suo sguardo sembra sconsolato. Davanti a lui
si svolge la Flagellazione. Il Cristo è legato ad una colonna
sormontata da una statua che rappresenta il sole. L’addetto alla Flagellazione
ha una tunica nera. Degli altri due personaggi, uno tiene Gesù per un
braccio, mentre l’altro indossa un turbante e osserva dando le spalle a
chi guarda il quadro.
In bella vista sulla destra ci sono tre personaggi: il primo è un uomo
barbuto vestito come gli orientali, il secondo è un giovane scalzo con
una tunica rossa, il terzo è un signore con un abito elegante in
broccato.
La luce proviene da due punti differenti, da sinistra e da destra, e
illumina anche la parte di soffitto posta sopra la testa del Cristo. Una
luce chiara e diffusa sembra bloccare ed immobilizzare le due scene. Il
quadro racconta i dolori del mondo, il presente, il passato e il futuro
dell’umanità. Giusto poi ricordare che le figure che stanno in fondo a
destra sono soltanto un doppio, una replica di quelle che si possono
vedere in primo piano sulla sinistra.
L’atto rappresentato sullo sfondo, pur riferendosi ad un fatto avvenuto,
è in realtà un atto unico, collocabile in qualsiasi tempo e, proprio in
virtù di tale qualità, assurge a valore eterno. Essendo entrato a far
parte del sacro, esso non ha tempo, è un fatto sia storico che
atemporale. La Flagellazione accade infatti nella più completa
indifferenza dei tre uomini che, pur condividendo il medesimo spazio reale
dove si compie il fatto, sembra non si accorgano nemmeno di quel che sta
succedendo a pochi passi da loro.
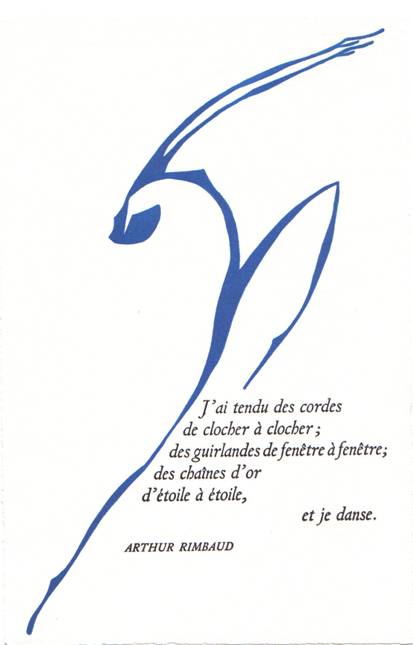
Un coeur simple è il
primo dei trois contes, e poi è anche lo scritto più bello
di Flaubert. Secondo Italo Calvino, “Il termine conte (invece di
récit o nouvelle) sottolinea il richiamo alla narrativa orale, al
meraviglioso e all’ingenuo, alla fiaba”.
Credo che in principio questo racconto fosse una canzonetta, una tiritera
che voltava e rivoltava nella testa di Flaubert, una cantilena che lo
stordiva, lo svegliava, lo confondeva, lo portava a fare un giro al largo.
Lo era in principio, e ogni tanto lo è anche adesso. Non saprei spiegare
altrimenti la fortuna di un testo impossibile da tradurre e che mai
nessuno è riuscito a ricreare.
“Un coeur simple”, dice ancora Calvino, “è un
racconto tutto di cose che si vedono, di frasi semplici e leggere in cui
avviene sempre qualcosa: la luna sui prati di Normandia che illumina buoi
sdraiati, due donne e due bambini che passano, un toro che esce dalla
nebbia e carica a muso basso. Felicité che gli getta della terra negli
occhi per permettere agli altri di saltare una siepe; oppure il porto di
Honfleur con le gru che sollevano i cavalli per depositarli nei battelli,
il nipote mozzo che Felicité riesce a vedere per un istante e che subito
scompare nascosto da una vela; e sopratutto la piccola camera di Felicité
gremita d’oggetti, ricordi della sua vita e della vita dei padroni, dove
un’acquasantiera in noce di cocco fiancheggia un cubo di sapone azzurro,
il tutto dominato dal famoso pappagallo impagliato, quasi un emblema di ciò
che la vita non ha dato alla povera domestica. E’ attraverso gli stessi
occhi di Felicité che noi vediamo tutte queste cose; la trasparenza delle
frasi del racconto è il solo mezzo possibile per rappresentare la purezza
e la nobiltà naturale nell’accettare il male il bene della
vita”.
Sento adesso il bisogno di voltare e rivoltare questo lavoro, di
scorciarlo come una ruota di bicicletta. Gustave Flaubert ricreava
canzoni, suonava l’arpa eolia e l’organetto di barberia. E poi
prendeva appunti sul suo taccuino. Credo che la storia di Felicité sia un
pretesto per riportare la natura in famiglia, forse anche una scusa per
completare “l’epopea del filo d’erba”.
Il cerchio chiude la sua circonferenza con un altro scarabocchio di
Calvino: “Sogno immense cosmologie, saghe ed epopee racchiuse nelle
dimensioni d’un epigramma. Nei tempi sempre più congestionati che ci
attendono, il bisogno di letteratura dovrà puntare sulla massima
concentrazione della poesia e del pensiero”.

Piccola
ala
Jimi
Hendrix Little
wing
| passa
tra le nuvole |
well
she’s walking through the clouds |
| con
un circo in testa |
with
a circus mind that’s running wild |
|
|
|
| favole e zebre |
butterflies
and zebras |
| e
lune e farfalle |
and
moonbeams and fairy tales |
|
|
|
| a
questo pensa |
that’s
all she ever thinks about |
| mentre gira nel vento |
riding with the wind |
| |
|
| se sono triste |
when i’m sad |
| lei mi viene a cercare |
she comes to me |
| |
|
| poi mi sorride |
with a thousand smiles |
| e mi porta lontano |
she
gives to me free |
| |
|
| va tutto bene |
it’s
alright |
| adesso
dice |
she
says it’s alright |
| |
|
| vola
piccola ala |
take
anything you want from me |
| vola
via |
fly
on little wing |


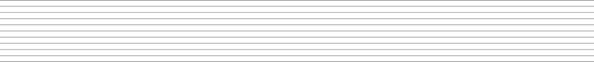


volta rivolta e torna a rivoltare

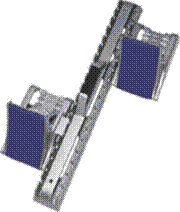
Anche se già ai tempi dell’antica Grecia
si usavano blocchi di pietra per consentire l’appoggio dei piedi, i
blocchi di partenza sono un’invenzione recente: furono introdotti in
atletica nel 1927 da George Bresnahan e William Tuttle, rispettivamente
assistente di Educazione fisica e docente di fisiologia all’Università
dello Iowa.
George
Simpson, il 9 giugno 1929, fu il primo atleta a farne uso duranti i
campionati NCAA; solo 10 anni dopo la commissione tecnica della IAAF
autorizzò l’uso dei blocchi, dando via ad una vera rivoluzione delle
tecniche di scatto e partenza nelle gare di atletica leggera. Prima di
allora gli atleti sistemavano i piedi in due buchette da loro stessi
scavate nella terra battuta o partivano in piedi.

La poesia
non sopporta nessun firmatario. Una volta prodotta, l’opera vive
un’esistenza propria e nessun autore dovrebbe attribuirsi quello che ha
scritto. Non credo ci siano rapporti diretti, e ancor meno di possesso,
tra il poema e il poeta. Lo scritto può portare il suo nome, ma resta
essenzialmente senza nome. Prima dell’opera lo scrittore non esiste
ancora, dopo non esiste più.

qui è sepolto un fulmine

Quando gareggiavo alla Columbia, ho
corso un paio di gare davvero bellissime. Durante la seconda, sapevo che
avrei vinto anche se non avevo nessuna buona ragione per crederlo, dato
che, quando mi passarono il testimone, il corridore che guidava la gara
era trenta iarde davanti a me. Ma io lo sapevo che avrei vinto, ed è
stata la mia “esperienza culmine”. Nessuno poteva battermi quel
giorno. Essere in piena forma e averne perfetta coscienza. Credo di non
essere mai stato così capace nel mio lavoro come quando corsi quelle due
gare: fu l’esperienza di essere al mio meglio e di fare un ottimo
lavoro.
Joseph
Campbell

Il
a toujours avec lui son crayon d’or, son petit cahier.
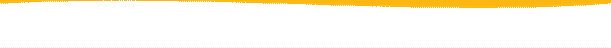
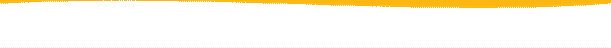
AUM” è una sillaba che alle nostre orecchie
rappresenta quel suono dell’energia dell’universo di cui tutte le cose
sono manifestazioni. Parti in fondo alla bocca con “ahh”, poi, con
“uu” ti riempi la bocca e con “mm” la chiudi. Se la pronunci in
modo adeguato, tutti i suoni delle vocali vengono inclusi nella pronuncia
AUM. Le consonanti vengono considerate come semplici interruzioni del
suono delle vocali. Così tutte le parole sono frammenti di AUM, proprio
come tutte le immagini sono frammenti della Forma delle Forme. AUM è un
suono simbolico che ti mette in contatto con quell’essere risonante che
è l’universo.

Chi
siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze,
d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è
un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un
campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e
riordinato in tutti i modi possibili.
Italo Calvino
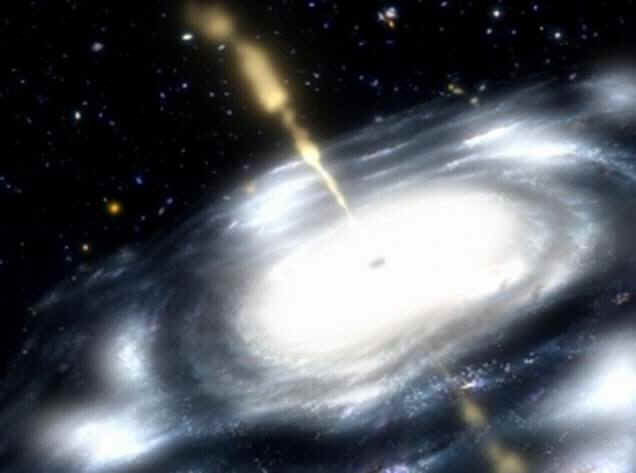
Il
mondo non è più, bisogna che ti sostenga.
Paul
Celan

Consumato
tutto il carbone; vuoto il secchio; inutile la pala; la stufa che respira
aria gelida; la stanza gonfia di gelo; davanti alla finestra, gli alberi
rigidi nella brina; il cielo, uno scudo d’argento contro chi cerca da
lui un aiuto. Devo procurarmi del carbone; non posso certo morire
congelato; dietro di me la stufa impietosa, impietoso il cielo davanti a
me; perciò devo andare al trotto in mezzo a loro, e nel frattempo,
cercare aiuto dal carbonaio. Questi però è ormai indurito contro le mie
solite preghiere; devo dimostrargli con chiarezza che non ho più neppure
la più piccola particella di carbone, e che dunque lui rappresenta per me
il sole nel firmamento. Devo arrivare come il mendicante intenzionato a
morire sulla soglia rantolando di fame, e al quale perciò la cuoca si
decide a lasciare i fondi dell’ultimo caffè; similmente il carbonaio,
pur schiumante di rabbia, ma sotto il raggio del comandamento "Non
uccidere!", dovrà scaraventarmi nel
secchio un’intera badilata.
Già il mio decollo sarà decisivo; e dunque mi metto a cavalcare sul
secchio. Da cavaliere del secchio, la mano in alto sull’impugnatura, che
è la briglia più semplice, scendo con difficoltà le curve della scala;
quando però sono giù, il mio secchio allora sale splendido, splendido; i
cammelli sdraiati bassi per terra, quando il bastone del padrone li
incita, non si sollevano con maggiore eleganza. Trottando a velocità
adeguata percorro le strade congelate; spesso mi sollevo fino
all’altezza del primo piano; non scendo mai fino alle porte
d’ingresso. E a straordinaria altezza mi libro sulle arcate della
cantina del carbonaio, dove questi sta rannicchiato laggiù al suo
tavolino scrivendo; per lasciar defluire l’eccessivo calore ha aperto la
porta.
"Carbonaio!" grido con voce arsa e arrochita dal freddo, avvolto
dalle nuvole di vapore del mio respiro, "per favore carbonaio, dammi
un po’ di carbone. Il mio secchio ormai è tanto vuoto che ci posso
cavalcare sopra. Sii buono. Appena posso te lo pago."
Il carbonaio mette la mano all’orecchio. "Ho sentito bene?"
chiede da sopra la spalla a sua moglie, che lavora a maglia vicino alla
stufa, "ho sentito bene? Ci sono clienti."
"Io non sento proprio niente", dice la donna, respirando
tranquilla sopra i ferri, piacevolmente riscaldata sulla schiena.
"Oh sì", grido io, "sono un cliente, un vecchio cliente,
un cliente fedele, solamente, per il momento impossibilitato a
pagare".
Moglie", dice il carbonaio, "è così, c’è proprio
qualcuno; non posso ingannarmi fino a questo punto; dev’essere un
vecchio, un vecchissimo cliente se sa toccarmi così profondamente il
cuore”.
"Che ti prende, marito?" chiede la donna, e riposandosi un
attimo preme sul petto il suo lavoro a maglia, "non c’è proprio
nessuno; il vicolo è vuoto; tutti i nostri clienti sono stati riforniti;
potremmo anche chiudere il negozio per giorni interi e riposarci."
"Ma io sono qui, seduto sul secchio" grido, e lacrime
insensibili di freddo mi velano lo sguardo, "per favore, guardate in
su; mi troverete subito; vi prego, datemi una palata di carbone; e se me
ne darete due, mi farete felice oltre misura. In fondo, tutti gli altri
clienti sono riforniti. Ah, se lo sentissi già risuonare nel
secchio!"
"Vengo", dice il carbonaio e con le sue gambe corte vorrebbe già
salire le scale della cantina, ma la moglie gli è già vicina, lo ferma
prendendogli il braccio e dice: "Resta qui. Se non la finisci con
questa idea, salirò io stessa. Ricordati che tosse hai avuto stanotte.
Per un affare, e per di più immaginario, dimentichi moglie e figli e
metti in pericolo i tuoi polmoni. Vado io." "Allora però digli
tutti i tipi di carbone che abbiamo in magazzino; io da sotto ti dirò i
prezzi." "Va bene", dice la moglie, e sale nel vicolo.
Naturalmente mi vede subito.
"Signora carbonaia", grido, "i miei saluti più devoti;
solo una palata di carbone; subito qui nel secchio; me la porto a casa da
solo; una palata del peggiore. Naturalmente la pago a prezzo intero, non
subito però, non subito." Che suono di campane, nelle due parole
"non subito", e come disorienta il loro mescolarsi con le
campane serali che proprio ora cominciano a suonare dal vicino
campanile.
"Allora, cosa vuole?" grida il carbonaio. "Niente",
gli risponde la moglie, "non c’è nessuno; non vedo nessuno, non
sento nessuno; solo hanno suonato le sei e noi chiudiamo il negozio. Il
freddo è terribile; c’è da prevedere che domani avremo molto
lavoro."
Non vede niente e non sente niente; però scioglie il grembiule e
agitandolo cerca di soffiarmi via. Purtroppo ci riesce. Il mio secchio ha
tutti i vantaggi di qualsiasi buon animale da cavalcare; ma non ha capacità
di resistenza; è troppo leggero; basta il grembiule di una donna per
cacciarlo a gambe levate.
"Cattiva!" le grido dietro, mentre lei, voltandosi verso il
negozio, agita la mano in aria un po’ sprezzante, un po’ soddisfatta
di se stessa, "cattiva! Ti ho chiesto una palata di carbone del
peggiore e tu non me l’hai data." E dicendo così salgo nelle
regioni delle montagne di ghiaccio e mi perdo per non tornare mai più.
Franz Kafka
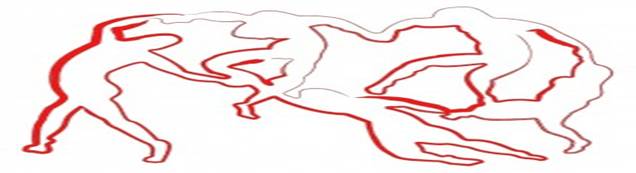
Partecipare
volontariamente e gioiosamente ai dolori del mondo non significa solo fare
esperienza del dolore in prima persona, ma anche partecipare con
compassione ai dolori degli altri. La compassione equivale al risveglio
del cuore dalla bestialità dell’egoismo all’interesse per l’umanità.
“Compassione” significa letteralmente “patire con”.

Dice
Ken Kesey: “E’ facile cominciare a indicare i problemi quando i
problemi sono sotto gli occhi di tutti. Chiunque sa trovare cacca di cane
in un parco. Ma sai trovare un giglio che cresce da questa merda? Quello
è il vero obiettivo: trovare una strada attraverso la merda di cane,
farla sbocciare”. Ma noi sappiamo già che c’è e non abbiamo proprio
bisogno che qualcuno ce lo dica. Tutte le ideologie, le religioni, le
politiche, vogliono convincerti del loro mondo. La sensibilità
psichedelica vuole convincerti del tuo mondo, della possibilità di dar
vita a infiniti mondi singolari. Qual’è lo stile di vita psichedelico?
L’ha detto Tom
Robbins: “Stanchi di aspettare che il mondo migliori, vivere come
se quel giorno
fosse già qui”.

Ombrosa
non c’è più. Guardando il cielo sgombro, mi domando se davvero è
esistita. Quel frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobi, spiumii,
minuto e senza fine, e il cielo solo a sprazzi irregolari e ritagli, forse
c’era solo perché ci passasse mio fratello col suo leggero passo di
codibugnolo, era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a questo filo
d’inchiostro, come l’ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di
cancellature, di rimandi, di sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a
momenti si sgrana in grossi acini chiari, a momenti si infittisce in segni
minuti come semi puntiformi, ora si ritorce su se stesso, ora si biforca,
ora collega grumi di frasi con contorni di foglie o di nuvole, e poi
s’intoppa, e poi ripiglia a attorcigliarsi, e corre e corre e si sdipana
e avvolge un ultimo grappolo insensato di parole idee sogni ed è finito.
Italo Calvino
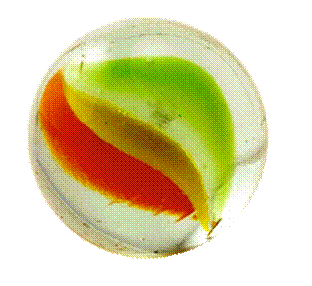
Apparaitre le moins
possible, non pas pour exalter mes livres, mais pour éviter la présence
d’un auteur qui prétendrait à une existence propre.
Maurice Blanchot
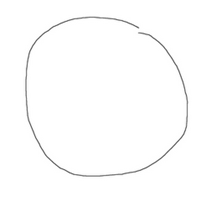

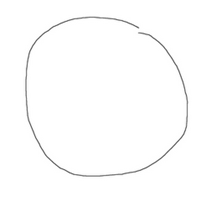
Quello che
non ti aspetti, dove non ti aspetti.

Non occorre che tu esca di casa. Resta al tuo tavolo
e ascolta. Non ascoltare nemmeno, aspetta soltanto. Non aspettare nemmeno,
sii assoluto silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per farsi
smascherare, non può fare altrimenti. Dinanzi a te si rotolerà estatico.
Franz
Kafka

Sento la mandorla nel guscio,
l’acqua nella terra, il fuoco nel ciottolo.
Joseph
Joubert

Perché ha scritto questo?
Non ho potuto fare diversamente.
Perché questa necessità di scrivere
non produce mai nulla che non appaia superfluo, vano e sempre di troppo?
Anche la necessità era già di troppo:
nell’obbligo di “non posso fare diversamente” c’è il sentimento,
ancor più impellente, che quest’obbligo non ha in sé la propria
giustificazione.
Maurice Blanchot

se non fosse per te
io non troverei la porta
non
troverei neanche la finestra
sarei solo e triste
se non
fosse per te
se non fosse per te
io non avrei mai sonno
aspetterei
la luce del giorno
e niente più cambierebbe
se non fosse per te
se non fosse per te
il cielo cadrebbe sulla terra
la
nuvola non darebbe pioggia
e io non potrei farci
niente
se non fosse per te
se non fosse per te
e tu lo sai che è vero
io
non sarei proprio nessuno
sarei perduto senza il tuo
amore
se non fosse per te
se non fosse per te
la primavera tornerebbe inverno
io
non sentirei cantare il grillo
e non sarebbe più vero
niente
se non fosse per te
Bob
Dylan



Un mendicante che prepara una supplica diversa
per ogni passante.


Sto
di casa nel verso, che va e va.
Paul
Celan

Sogno immense cosmologie, saghe
ed epopee racchiuse nelle dimensioni d’un epigramma. Nei tempi sempre più
congestionati che ci attendono, il bisogno di letteratura dovrà puntare
sulla massima concentrazione della poesia e del pensiero.
Italo Calvino

Mantenere la natura in famiglia. Fare, come
diceva Flaubert, “l’epopea del filo d’erba”.

Loris Pattuelli
|
Ricerche
sull'anima di Alfonsine
|
|