La
IV e V Festa dell'Uva del '33 e del '34
Durante
la IV Festa dell'Uva tenutasi l'8 Ottobre del 1933, il
podestà Mariani e il Comitato di Alfonsine pubblicarono un
"Numero unico folkloristico vendemmiale" di
otto pagine con vari inserti fotografici (molti dei quali
riprodotti qui) che documentano in modo unico e
assoluto come si svolgeva la festa.
Alla
coreografia rituale del corteo folkloristico dei carri, nel
'34 si aggiunsero de gruppi appiedati e a cavallo, in costuni
storici o tradizionali, e oltre ai carri c'erano anche
birocci, calessi, tricicli e carrozzini opportunamente
decorati di motivi vendemmiali e simboli del fascio, allestiti
tutti in gran segreto per timore di essere copiati. In
entrambe le edizioni furono messi in palio decine di premi in
denaro e distribuiti a tutti i partecipanti diplomi di
partecipazione e cestini di pane e uva 'appositamente
conditi su ricetta del podestà'.
Particolare cura fu
dedicata anche all'apparato scenografico di piazza Monti e di
Corso Garibaldi, dove si svolgeva la sfilata: grappoli e
tralci d'uva, cartelli e strisce multicolori inneggianti al
Duce, bandiere e stendardi, luminarie di vari colori.
Nel
'34 ci furono anche alcune 'originali creazioni: un
gigantesco grappolo collocato dall'industriale [Giuseppe ndr]
Marini al sommo della sua casa e la fontana vendemmiale
felicemente ideata dal Prof. Pasini) (tratto da un
articolo pubblicato in Santa Milizia del 13 ottobre 1933, p.
3)
Secondo
le cronache assistettero alla festa del '33 e poi anche a
quella del '34 circa 15.000 persone.
Venivano
da tutti i paesi vicini e anche da qualche città. Ma quanti
erano?
Così
si chiede in un articolo il segretario del fascio di Alfonsine
Arturo Taroni:
“Quanta
gente ha gremito la piazza (Monti ndr) in quella
indimenticabile giornata? un tale, con cifre alla mano, ha
creduto di potervi rispondere con certezza, fissando in 15.000
il numero dei convenuti alla manifestazione. Calcolando egli
ha spiegato, che i due lati maggiori della piazza misurano
all’incirca m. 80x120: si ha una superficie totale di 10.200
(qui
l’autore ha commesso un grossolano errore di calcolo
perché il prodotto dà 9.600 ndr), escluso dal
computo l’adiacente piazzetta della Chiesa, tenuto conto
della minore densità di folla, valutando a due il numero di
persone per metro quadrato, il totale che ne deriva è sempre
superiore al numero sopra menzionato di 15.000” (due
persone per metro quadro sembrano un’esagerazione, il
fascismo riusciva a piegare anche i numeri al proprio volere .
ndr)
Così
recitava un articolo tratto dal numero unico di un opuscolo in
forma di giornale, pubblicato dai fascisti alfonsinesi
nell’occasione della IV Festa dell’ 8 ottobre anno XI (1933):
Titolo“Sulle
orme del fascismo”:
Il
social-nazionalismo vede nel contadino la pietra più solida
dell’edificio che ospita la società umana. In un recente
discorso Hitler ha affermato essere naturale che la
rivoluzione delle Camicie brune coinvolga nel suo turbine
rigeneratore in modo particolare il ceto rurale; l’elemento
più prezioso della Nazione, che feconda la terra e nutre
l’umanità.”
E'
evidente che la Festa dell'Uva era una manifestazione
di mobilitazione popolare che mirava a creare un altro
tassello di quella liturgia di massa del fascismo, non
smaccatamente politicizzata, e quindi più adatta a influire
sulla mentalità delle masse, ancora diffidenti o
recalcitranti ai messaggi sfacciatamente ideologici.
Data
la notorietà a livello regionale raggiunta dalla Festa
dell'Uva di Alfonsine, il podestà Mariani inviò nel 1934 al
direttore dell'Istituto Luce una prima richiesta di ripresa
cinematografica della manifestazione, seguita da altre in anni
successivi: tutte purtroppo con esito negativo.
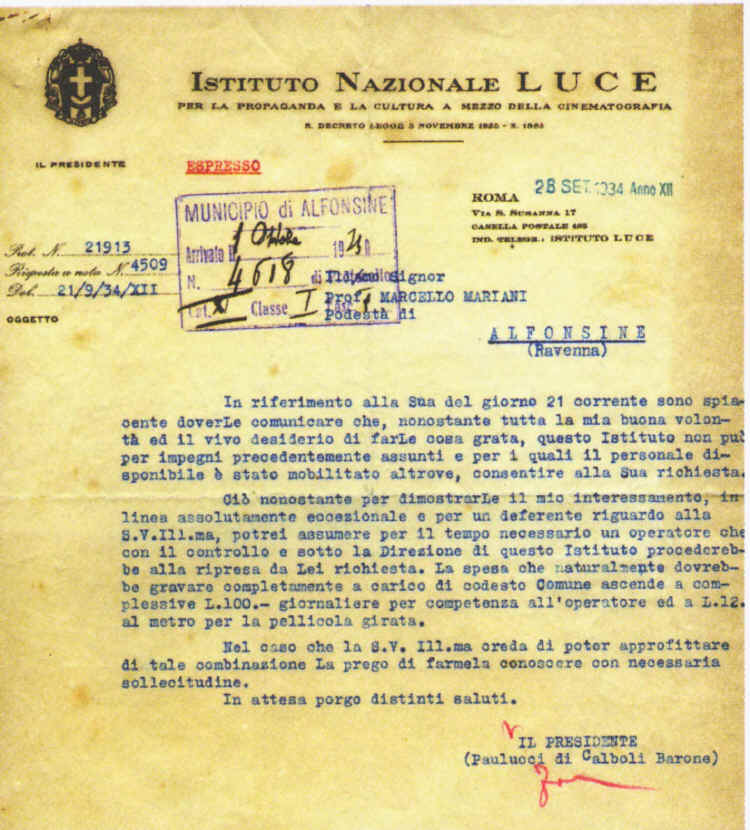
Ma
era
veramente una festa popolare
a cui tutti gli alfonsinesi partecipavano?
Le
foto dimostrano che era veramente una festa popolare a cui
tutti partecipavano. Il fascismo era ormai affermato e
vincente.
La Festa dell’Uva era posta come alternativa alla
festa dei lavoratori del 1° maggio, che era stata abolita dal
fascismo, e che nei primi anni venti era stata occasione di
scontri violenti anche ad Alfonsine, perché le squadre
fasciste intervenivano alla Festa dei Lavoratori provocando,
manganellando e a volte sparando.
Il
cronista del giornale esprime così il suo giudizio:
“....
vera festa di popolo (Festa dell’Uva ndr), che ha portato un
raggio di luce e un’onda di calore nel grigiore della vita
quotidiana di ognuno. Vera festa civile, ad un tempo, perché
purificata di tutte quelle contrastanti passioni, che
rendevano incivile la festa dei lavoratori, di tempi ormai,
spiritualmente lontani. “Ad maiora!”
Feste
di borgata
Ad
esempio nel quartiere Borse si svolgeva una
festa del borgo,
non nel periodo della festa dell’uva, dove il clou
era nel gioco della Cuccagna.
Qui
non c’era messaggio fascista che potesse passare, né
personaggi in divisa che potessero partecipare, (ci si
imbrattava di grasso e cenere!): qui era proprio la gente vera
del popolo, che si arrampicava su per quel palo per vincere un
prosciutto o un fiasco di vino: lo spirito di un tempo, prima
del fascismo, ritornava del tutto a galla.
E
questo poteva far ancora paura anche a un fascismo, pure
ormai vincente.
Una
festa simile era quella di "Sant'Apollonia" che si
teneva il 9 febbraio lungo il borgo della via
Reale. (E'
l'unica festa tradizionale rimasta ancora oggi 2004)
Nella
Festa dell’Uva però, come si è scritto sopra, venivano coinvolte persone
“importanti” del paese, che non erano fascisti convinti,
ma per le quali era ormai d’obbligo stare al gioco, come il
direttore dell’ospedale Umberto Pasini o l’arciprete don
Liverani.
La
loro collaborazione era strumentalizzata come un messaggio che
tentava in qualche modo di caratterizzare la festa come non di
parte.
Nel
ringraziamento del podestà Marcello Mariani a coloro che avevano collaborato
alla buona riuscita della festa del 1933 si citano espressamente il “Rev.
Dott. Luigi Liverani, Arciprete, che ha benedetto l’uva sulla pubblica
piazza e ha poi ricevuto, con ogni attenzione, una rappresentanza del Comitato
in Arcipretale, per assistere alla Messa , da egli stesso celebrata per
l’occasione.”
E
ancora “il Prof. Umberto Pasini che ha messo a punto e diretto il corteo
perché fosse possibile quella sfilata che, per intelligente disposizione dei
gruppi e delle masse, ha suscitato l’unanime entusiasmo e il vivo consenso
dell’autorità.”
Umberto
Pasini (proprio in quell’anno 1933 si era iscritto al
fascio, insieme a un’altro dottore un po’ recalcitrante, il dott. Preve,
segno che evidentemente non c’erano più spazi per rimanere senza tessera)
scrisse un articolo nel medesimo giornale, in cui tra l’altro elogiava il
ruolo terapeutico dell’uva nella dieta quotidiana, per avere una vita più
sana.
Ma alla
fine indulge anche lui in una tirata propagandistica a favore del duce:
“Perciò
scienza ed esperienza dimostrano,
- così scriveva il dott. Pasini - che il consumo dell’uva deve
essere ogni giorno più allargato, per avvantaggiare la nostra salute ed
allietare la vita dello spirito, coincidendo l’interesse scientifico-sociale
con quello della difesa economica del nostro paese. Così scrive il Duce: I
medici debbono insistere perché la vita si svolga in forma più razionale; ci
saranno allora meno malattie in giro, meno tubercolosi, meno cancro...”.
E concludeva “Sempre e dovunque, fervido istigatore
(Mussolini
ndr), aleggia lo spirito suo!”.
La
VI Festa dell'Uva del 1935
Nell'ottobre
del 1935 era iniziata la guerra coloniale fascista in Etiopia,
che richiese un'enorme mobilitazione di forze militari e
umane. La chiamata alle armi e la conseguente assenza di molti
giovani del paese che 'contribuivano non poco alla riuscita
della festa specie nell'allestimento dei carri,' impedì
che la festa dell'Uva di Alfonsine fosse celebrata 'con
quella grandiosità che era diventata, oramai, un'ammirata e
invidiata tradizione' (dal Carteggio amministrativo 1936,
cat. II, cl 1 Archivio Storico Comunale di Alfonsine),
costringendo il Comune e il Comitato Organizzatore a
predisporre un programma fissato in sobrie manifestazioni.
La
VII Festa dell'Uva del 1936
Questa
festa fu posticipata per consentirvi la partecipazione dei
soldati alfonsinesi dell'81° Battaglione impegnati in Africa
orientale. Nel corteo sfilarono carri che richiamavano la guerra
in Africa come il carro "Faccetta nera" e
"Potenziamento dell'impero" che ottennero il secondo e
il terzo premio. Quest'ultimo, allestito dai Giovani Fascisti,
riproduceva un tucul circondato circondato da bambini in divisa
coloniale e 'mascherati' da indigeni, sormontato da un grande
stendardo con l'emblematica scritta 'te teneo leo'.

Anche
la scenografia del paese venne ulteriormente spettacolarizzata:
sul modello di Roma imperiale fasci littori e severe
colonne sormontate dall'aquila romana' delimitarono
i corsi e gli ingressi principali della piazza.
Coerente
invece col tema vendemmiale della festa fu l'ingegnosa fontana
sprizzante canéna a getto interrotto eretta dal
Dopolavoro aziendale Marini davanti alla propria sede.



Piazza Monti: festa
dell'Uva del 1936
Il TUCUL e la scritta "Te teneo Leo" era rivolta alla
conquista dell'Eritrea (Abissinia) e alla sconfitta del Re Haillè
Sailassié.

Piazza Monti: festa
dell'Uva del 1936

Piazza Monti: festa
dell'Uva del 1936
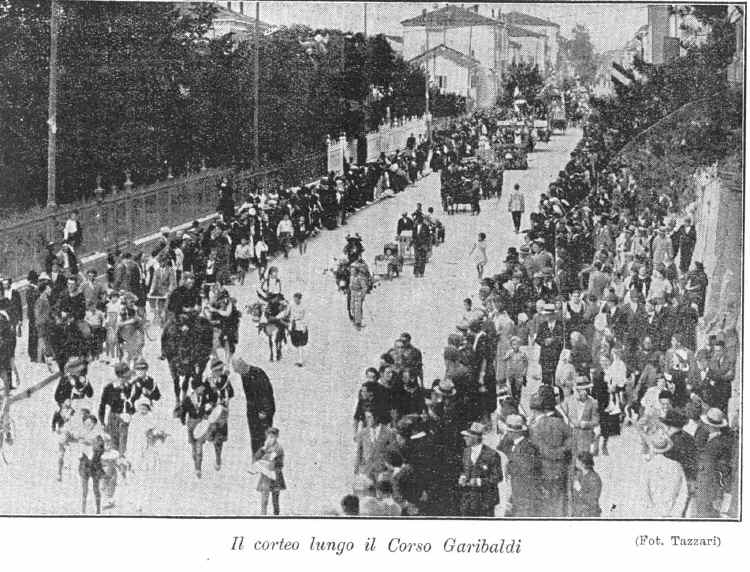
Il
corteo dei carri in corso Garibaldi

La
VIII e la IX Festa dell'Uva del '37 e '38
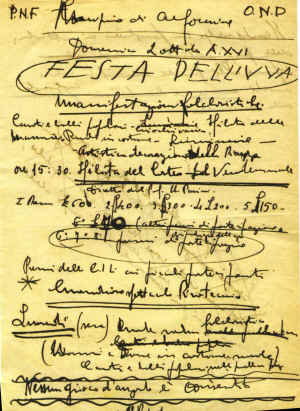
Bozza
di programma per la festa dell'Uva del 1937
Anche
le feste del '37 e '38 ebbero un grande successo con ampi finanziamenti
sia pubblici che privati, festa alla quale 'i cittadini molto
mal volentieri rinunzierebbero, specie i commercianti, che
risentirebbero dei suoi benefici effetti' (così recita la
delibera del podestà Mariani, per motivare la necessità di
continuare tale festa.
Il
comitato organizzatore della IX edizione raggiunse il numero di 26
membri, lo stanziamento comunale fu aumentato a 5.500 lire e i
contributi di enti e associazioni ammontarono a 2.000 lire.
La
celebrazione, che già da alcuni anni proseguiva anche nella
serata del lunedì, si articolò secondo il consueto copione,
con un evidente accentuazione di temi politici come la nascita
dell’Asse Roma-Berlino e poi il Patto d’Acciaio, come si
nota in alcuni dei carri folcloristici.
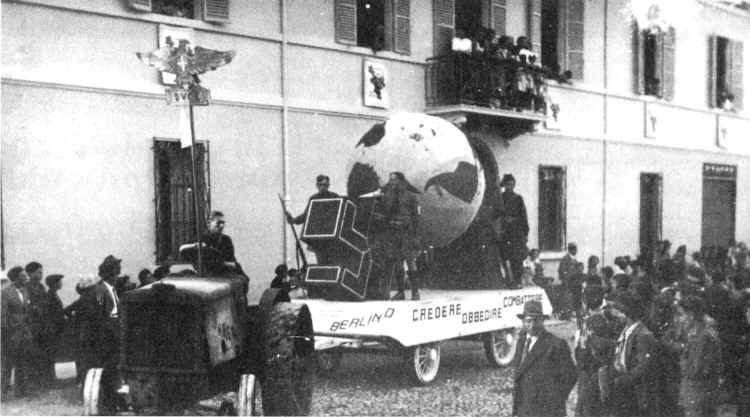
Una
Festa dell’Uva del 1937
L’Asse Roma –
Berlino è propagandata da questo carro
che sta passando sotto la casa dei Santoni, in
piazza Monti
Il
secondo premio lo vinse il carro "Asse Roma-Berlino",
raffigurante un fascio ed una svastica che sorreggevano il
mondo, omaggio in chiave rurale del primo anniversario
dell'alleanza italo-tedesca. Il carro ottenne poi un secondo
riconoscimento: il premio
speciale della giuria per 'la sua alta significazione
politica'.
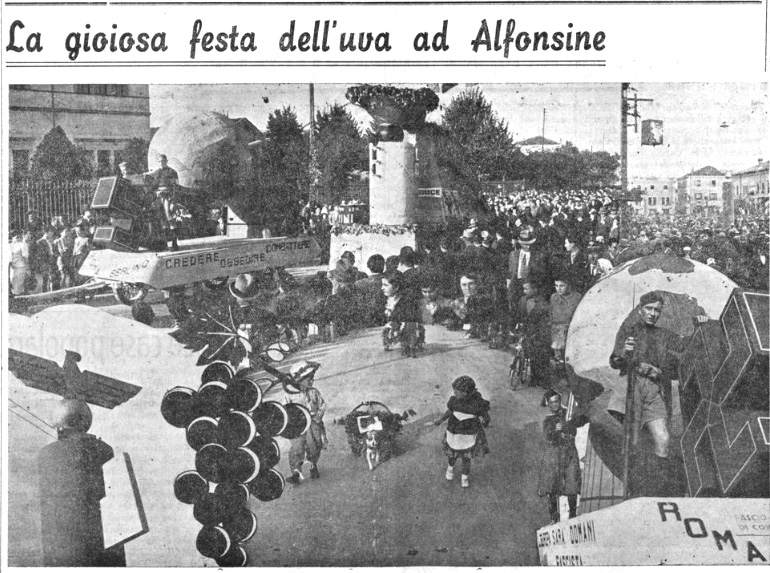
Dal
settimanale la Santa Milizia del 1937 (n° 41 pagina 2)

Un
carro
della Festa dell'Uva del 1938
mentre passa davanti alla chiesa S. Maria di
piazza Monti
|
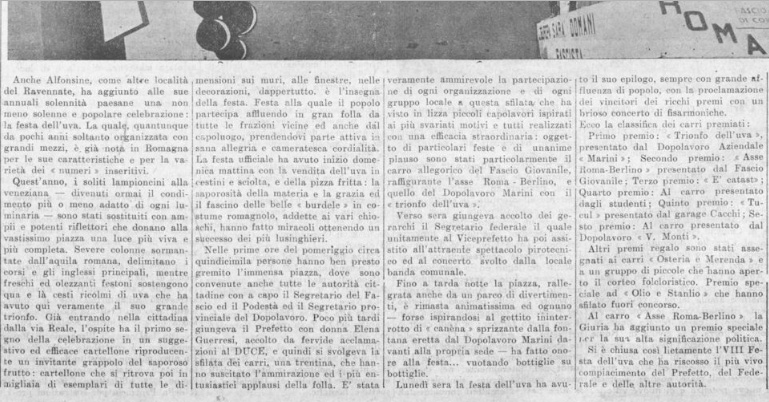
Dal
settimanale la Santa Milizia del 1937 (n° 41 pagina 2)
|
|
La
X, XI e ultima Festa dell'Uva del '39, '40 e '41
Nelle ultime
edizioni della festa venne allestito anche un 'parco giochi' dedicato
a forme itineranti di divertimento: molte le richieste inviate al
podestà e conservate in archivio da tutta Italia, per ottenere la
concessione di spazi da adibire a tiri al bersaglio, giostre volanti,
autopiste e spettacoli viaggianti. la IX Festa fu l'ultima
caratterizzata da grandiosi festeggiamenti che avevano affermata la
manifestazione alfonsinese a livello regionale.
Il corteo fu
abolito nella X Festa, e rimase solo il parco giochi e lo spettacolo
pirotecnico.
Dal 1940
l'organizzazione della Festa venne demandata al locale Dopolavoro, che
organizzò per quell'anno una corsa ciclistica in memoria del
compaesano Ettore Rambelli, caduto a Tobruk, e l'anno successivo una
partita di calcio fra le squadre della Gioventù italiana del
Littorio
|