|
II
conte Zanelli si indebitò in modo esagerato per finanziare l'opera.
Ma il nuovo canale iniziato nel 1778 e
inaugurato nel 1782 non ebbe molta
fortuna.
Alcuni privilegi
furono accordati al Conte Zanelli, tra cui quello di piantare alberi sugli argini e sull'orlo
dei fossi delle strade adiacenti al Canale. Furono
piantati 70 mila pioppi, In tre anni le parti essenziali del Canale
erano state completate ed immediatamente l'acqua del Lamone fu fatta
scorrere nel suo alveo tramite un canale proveniente dal fiunme
Lamone presso Faenza, fino a Porta Pia.
Rilevante, ai fini dell'incentivazione del commercio
fu
l'esenzione dai dazi per le merci provenienti sia dallo Stato Pontificio che dagli altri Stati attraverso l'Adriatico e ll Po di
Primaro.
Fieno,
granaglie, legumi e prodotti delle colline. legname da lavoro, canapa, vino e erbe palustri furono i
pochi articoli che si mossero lungo questa via d'acqua, mentre le
torbide del Lamone, che tenevano alimentato il canale, ne causavano
anche il progressivo interramento.
In
più furono costruiti anche otto mulini da grano lungo il canale,
così le merci potevano
solo essere caricate su chiatte e
trascinate, dalle sponde, da coppie di buoi.
Per consentire sia il loro transito
che il lavoro dei mulini, in prossimità di questi ultimi furono
costruite delle chiuse il cui funzionamento riproduceva in piccolo
il sistema adottato per il Canale di Panama.
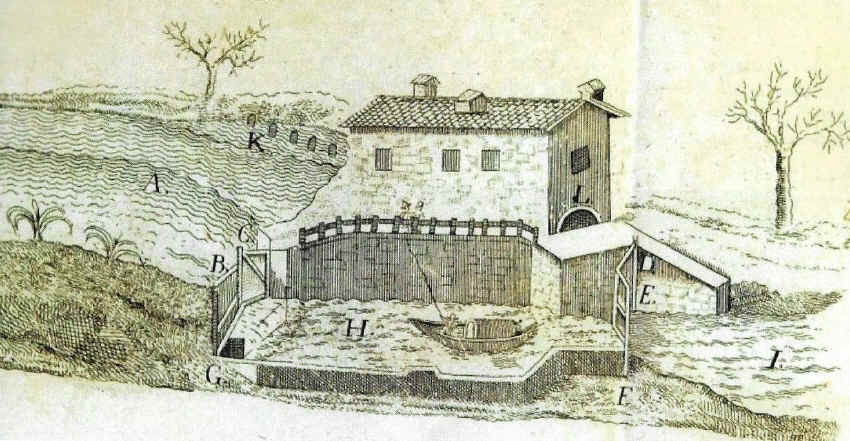
Disegno di un Sostegno o chiusa, di cui ne furono costruite 11 sul tracciato del Canale Naviglio.
Fornito di due porte vinciane (B, E), questo era lo stesso sistema che verrà poi usato anche nel Canale di Panama per navigare aree a diverso livello
(A - I). Costruito vicino ai mulini (L) o ad altri opifici veniva usato anche come traversa per attivare meccanismi generatori di energia (ASR, Sezione di Faenza, Opera del Canale Naviglio Pasolini Zanelli, Vol. III).
(un
click o un tocco per averne un ingrandimento)
I ponticelli, con la
classica struttura a dorso d'asino, avevano la funzione di sostegno
delle porte delle chiuse realizzate per
consentirne la navigazione.
Mantenere la
navigabilità divenne sempre più difficile e costoso.
II comune
stesso di Faenza giunse a disconoscere l'utilità di tale opera,
dopo averla inizialmente sostenuta (ma c'è da dire che il conte
Zanelli aveva avuto uno 'sponsor' di tutto riguardo, e cioè
l'allora Papa Pio VI, di cui era cugino).
Sorsero
questioni gravi tra il comune
di Faenza e il conte sull’uso dell’acqua che doveva tener
alimentato il canale; alla fine tra liti, processi e accomodamenti,
il tutto subì un degrado continuo.
L’opera iniziò nel 1778, prima con la costruzione
delle fornaci per produrre mattoni, poi con gli scavi in dicembre
dello stesso anno, per terminare in tempo di record solo tre anni
dopo, considerando che nell'intero progetto si usarono solo buoi,
aratri ed energia muscolare.
L'opera
fu inaugurata ufficialmente il
20 gennaio 1783, con il conte Zanelli che risalì a bordo di una
barca il tratto da Bagnacavallo a Faenza e una moltitudine di gente
a far da corona al memorabile evento. Pochi
mesi dopo fu lo stesso Papa Pio VI a benedire l’opera pressoché
terminata. Di ritorno da Vienna, il 29 maggio sosta in città per un
breve riposo nell’abitazione del cugino e può quindi recarsi
sulle mura da dove, sotto un arco trionfale eretto in suo onore,
osserva con interesse il canale e le costruzioni della
darsena.
In
quel luogo, a ricordo della visita e su espresso consenso del Papa,
verrà aperta Porta Pia.
Nelle settimane seguenti il canale era già in servizio, anche se ci
vorranno altri sei-sette anni per portare a termine la costruzione
di otto mulini. Apposite chiuse (11) furono sistemate vicino ai
mulini per facilitare il movimento di zattere, simile alle chiuse
poi costruite sul Canale di Panama.
Furono
costruiti quindici ponti "a schiena d'asino", dieci
botti a scifone sotterranee, tre magazzini e abitazioni per i
barcaioli, guardiani ed altri funzionari, cinque maceri per
lavorazione della canapa e del lino.
La
struttura del Canale
Misurava da Faenza al Reno 7.424 pertiche e otto piedi faentini (circa 36 km), lungo gli argini erano stati messi a dimora più di 70mila pioppi.
La spesa totale verrà stimata nel 1815 dall’ing. Giuseppe Morri
in quasi 118mila scudi, calcolando oltre la costruzione del Canale
tutto il resto la cifra si aggirò sui 300 mila scudi romani.
Il dislivello era di 34 metri: 24 m. da Faenza e Bagnacavallo e 10 m. da Bagnacavalio a Magazzeno.
Nel primo tratto le pendenza
media era di m. 0.44 per Km., nel secondo tratto di m. 0.15 per Km.
La portata media
era di litri 2.000 al minuto: la velocità media era di m. 0.33 per secondo. Tale portata di litri 2.000 si
aveva solo per circa sette mesi dell'anno, mentre negli altri mesi discendeva a valori minori, secondo la maggiore o minore siccità. Un particolare
sistema di vasche permetteva il deposito del limo trasportato dall'acqua immessa nel canale.
L'alveo del Canale
fu diviso da nove sostegni (le chiuse) in undici tronchi di diversa inclinazione ed estensione quali richiedeva
la planimetria dei terreni per impedire lo scarico veloce dell'acqua e sostenerla alla superficie quasi
orizzontale all'altezza necessaria per la navigazione. Ma poiché l'acqua fermata dal
sostegno ("chiusa"), per quella che continuamente
sopravveniva, sarebbe cresciuta sempre, aumentando sino a superare le
arginature e si sarebbe poi diffusa per le campagne adiacenti, a scopo di evitare ciò ogni sostegno
("chiusa") venne, nella parte
superiore munito di uno sfogatore il quale riceveva le acque quando
giungessero a sorpassare un regolatore fisso e le mandava nel tronco
inferiore.
Da Faenza
al Magazzeno del Reno ricordiamo che i magazzini erano tre: uno all'inizio, uno a metà, situato fuori di
Bagnacavallo, e uno alla fine, a Magazzeno, appunto.
Sulla strada al lato sinistro del
Canale per una lunghezza di Km. 16 fino a Bagnacavallo si trovavano sette sostegni
("chiuse")
con cinque
mulini; da Bagnacavallo sino al magazzino situato alla destra del Po di
Primaro, in vicinanza allo sbocco del canale per una lunghezza di Km. 17
esistevano quattro sostegni, con altri tre mulini.
Terminata
l'opera nel
1788, nel 1790 era già in crisi.
"Nel 1789 furono caricate e scaricate, nel porto del Naviglio, 304 barche di mare con 40.729 colli di mercanzia; nel 1790, 492 barche con 67.136 colli di mercanzia.
(così scrisse Pietro Alberto Zanelli Quarantini, "il Canal
Naviglio Zanelli", Bologna, 1923).
Il canale non era stato costruito nel pieno rispetto
delle clausole contenute nel chirografo pontificio e - affermarono i
più critici - da opera di pubblica utilità aveva finito per
trasformarsi in un monopolio dei Zanelli.
Il transito avrebbe dovuto essere consentito a tutte le barche,
salvo il pagamento di dazi o pedaggi, ma in realtà i ponti in
muratura lo rendevano di fatto impossibile. Le sole a poter
percorrere il canale erano le chiatte fatte costruire dal conte
Zanelli, prive di strutture soprelevate e cedute in nolo.
Furono
queste limitazioni e le conseguenti controversie a far perdere ben presto di
importanza al Naviglio e a non consentirgli di costituire quel
fattore di sviluppo e di prosperità
nel quale tanti avevano sperato.
Fallito l'obiettivo del trasporto
dall’Adriatico al Tirreno, Zanelli si preoccupò del funzionamento
degli otto mulini da grano costruiti lungo il canale, da cui trasse
un sufficiente guadagno, ma non tale da compensare la delusione per
l’insuccesso della sua impresa: amareggiato e deluso, e per di più colpito
dalla malaria, morì a Roma il 19 gennaio 1792 trovandovi sepoltura
in S.Onofrio.
Nel
testamento dispose che ogni anno le entrate del canale Naviglio e
delle attività che sullo stesso erano sorte, detratte le spese,
fossero ripartite in misura uguale e che una delle due parti venisse
“erogata in sovvenimento ed a soccorso dei poveri di Faenza”.
Un atto da grande benefattore, ma
di nuovo i problemi non tardarono
a manifestarsi.
Non
aveva mai contratto matrimonio, per cui nomino suo erede,
la sorella
Giacoma, vedova del Conte Pietro Pasolini di Cesena, con l'obbligo di passare l'eredita intera al di lei figlio Antonio
Pasolini,
che al proprio nome unì
quello dello zio, donde il sorgere d’una nuova branca di questa
casata, i Pasolini Zanelli.
La vertenza fra
l’Amministrazione pubblica faentina e la Congregazione del canale,
che lo gestì dopo la morte del conte Zanelli, si protrarrà per
decenni.
Secondo il testamento di Scipione Zanelli, per il Canal
Naviglio fu composta una Congregazione con a capo Pasolini Zanelli, che aveva, tra
l'altro, obblighi di beneficienza, come si è visto sopra.
Nel 1860, a causa della costruzione della ferrovia, il
canale non si utilizzò più per la navigazione, ma solo per il
funzionamento degli otto mulini.
Essendo il Naviglio alimentato dalle acque del Lamone scorrenti nei canali di Faenza ed avendo la chiusa, che immetteva l'acqua nel
canale, causato danni rilevanti al terreno circostante, il Comune di Faenza tentò a lungo di subentrare nella proprietà del Naviglio. Vi riuscì solo
quando, alla morte del Conte Senatore Giuseppe Pasolini Zanelli, avvenuta il 12 marzo
1909, i suoi beni vennero posti all'asta dall'erede. (Si veda la ratifica della delibera della Giunta da parte del Consiglio Comunale in data 2 giugno
1910).
Infine, un decreto del
ministro dell'Interno 8 marzo 1914 stabilì fra l'altro che la Congregazione del
Canal Naviglio Zanelli, con sede nel Comune di Faenza,
fosse dichiarata limitatamente alla metà del suo patrimonio destinato a beneficio dei poveri, istituzione di pubblica beneficenza.
IL
PERCORSO DEL CANALE NAVIGLIO
Il Canale iniziava a Faenza con la darsena presso Porta Pia dove furono costruiti appositi magazzini per le derrate e manutenzione.
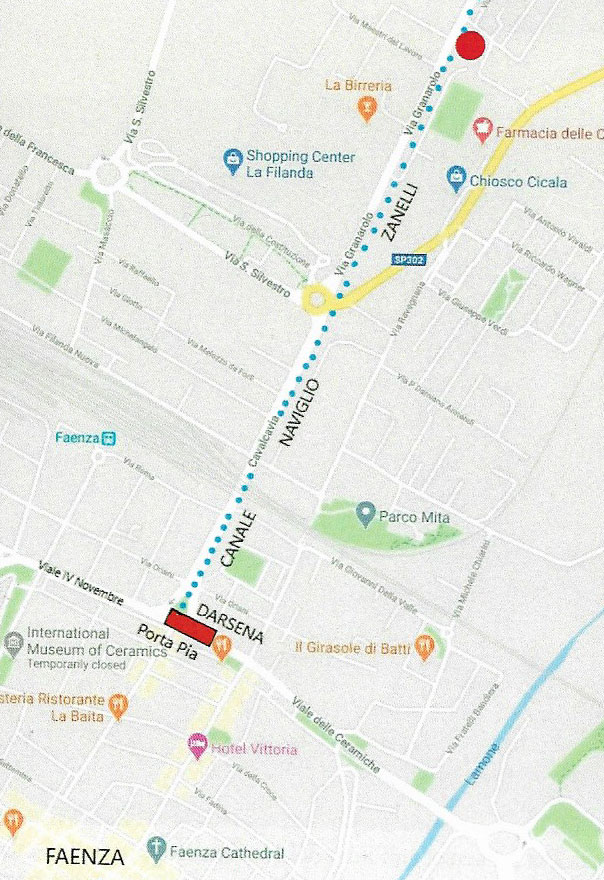

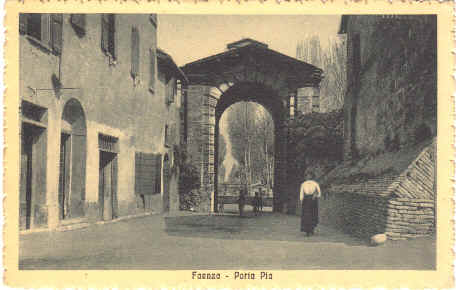
Il
canale Naviglio qui sopra all'inizio a Faenza,
il
campanile sullo sfondo è quello della chiesa di S. Chiara.


Il
canale Naviglio alla darsena di Faenza,
con la
veduta
di Porta Pia. Oggi
corrisponde alla zona di piazzale Sercognani. 
DA
FAENZA A GRANAROLO
Dopo Borgo San Rocco il Canal Naviglio seguiva a est la via Granarolo.
Qui c'era il primo degli otto mulini, il Mulino San Rocco (poi Morini), uno
dei due ancora esistenti. 
Veduta
del Canale Naviglio nel Borgo San Rocco a Faenza ad est di Via Granarolo, visto dal nord.
Si vede il primo Sostegno (o Chiusa) di fronte al Mulino San Rocco, poi Morini, da un disegno di Romolo e Tancredi Liverani del 1840:
mostra anche sulla sinistra il canale emissario del mulino e le porte vinciane, parzialmente aperte. Sullo sfondo a sinistra è visibile il
campanile della Chiesa di S. Ippolito e al centro Porta Pia. 

Il
canal Naviglio qui è stato tombato:
il mulino funziona a energia elettrica A
Granarolo

Il
canale Naviglio a Granarolo alla
fine '800.

Gli
argini del Canal Naviglio servivano come pascolo
per i greggi di pecore
DA
GRANAROLO A BAGNACAVALLO

Il
Canal Naviglio a Bagnacavallo alla fine '800.
Da Faenza,
dopo Granarolo il Canale proseguiva,
e prosegue a tutt'oggi, verso Bagnacavallo alla destra della SP 8 che lo
accompagna, dopo aver passato dalla darsena di Bagnacavallo presso Porta Superiore e ad est della
città. Qui era stata costruita la Darsena, con magazzini per merci e un
mulino ad acqua (demolito nel 1862)

Il "Vecchio Mulino" o "Mulino
Randoni" a sud di Bagnacavallo.
Unico degli otto mulini con canale centrale, mentre gli altri avevano una canaletta secondaria con successivo canale di rientro a nord del mulino, per non ostruire la navigazione. Questo mulino fu costruito dopo il 1860, quando ogni forma di navigazione commerciale era cessata per insabbiamento del canale.
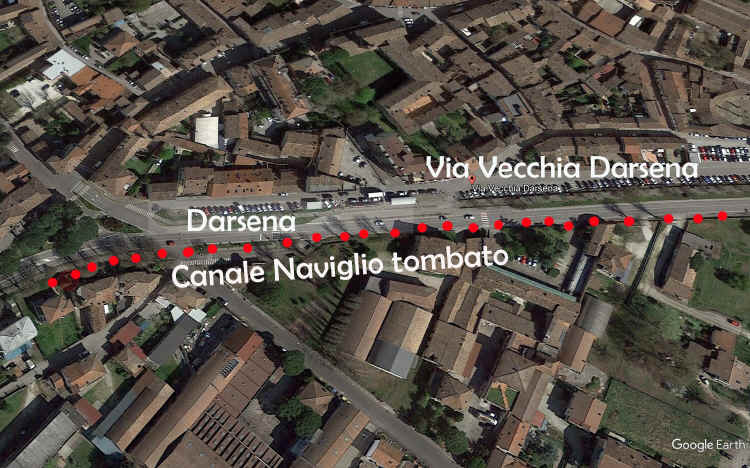

Mulino
detto di Porta Superiore sul Canale Naviglio Zanelli
(foto del 1915).
Questo mulino fu costruito nella seconda metà del XIX secolo, dopo che era stato demolito il mulino della Darsena nel 1862. A questo punto la navigazione aveva perso la sua importanza, definitivamente abbandonata nel 1860, perciò il canale poteva passare al centro del mulino (foto di Don Cesare
Proni)
DA
BAGNACAVALLO A VILLA PRATI
A
nord di Bagnacavallo, verso Villa Prati, sulla destra del Canal Naviglio, si
trova il secondo degli otto vecchi mulini rimasto in funzione: il Molino della
Viola (poi Molino Quercioli)
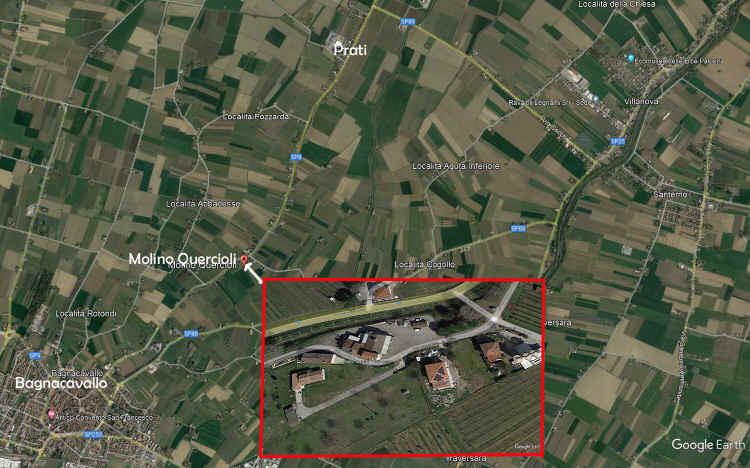

Molino della Viola (poi Molino Quercioli) su Via Destra Canale tra Bagnacavallo e Villa Prati (foto Giovanni
Baldini)


Macine
antiche del molino
A
Villa Prati c'era un altro degli otto
molini del Naviglio.
Oggi non c'è
più il mulino, ma è la sua costruzione è diventata una residenza
privata. è
rimasto il ponticello ad arco.
(un
click o un tocco per averne un ingrandimento)
|
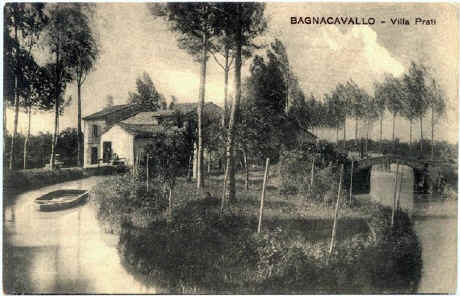 
|
|
Nella
prima foto sopra a destra si vede il ponte del mulino di Villa
Prati. è lo
stesso
ponte che è rimasto in piedi ancora oggi (foto 2)
Si
vede anche in entrambe le foto una delle zattere a fondo piatto, dette
"sandaloni" perché
costruite a forma di "ciabatta": venivano
appositamente noleggiate e potevano essere usate per navigare.
Le
foto sotto mostrano il ponticello in varie fasi fino al suo
recupero, e in alcune si vede l'edificio residenza privata,
che un tempo era il Molino.
(un
click o un tocco sulle foto per averne un ingrandimento)
|
|


|
|


|
|


|
Il
ponte del molino di Villa Prati ristrutturato nel
2018

DA
VILLA PRATI AD ALFONSINE
Il Canal Naviglio
da Villa Prati arriva
fino alla Via Reale (SS 16) per poi immettersi nel Po di Primaro a nord-est di
Alfonsine.
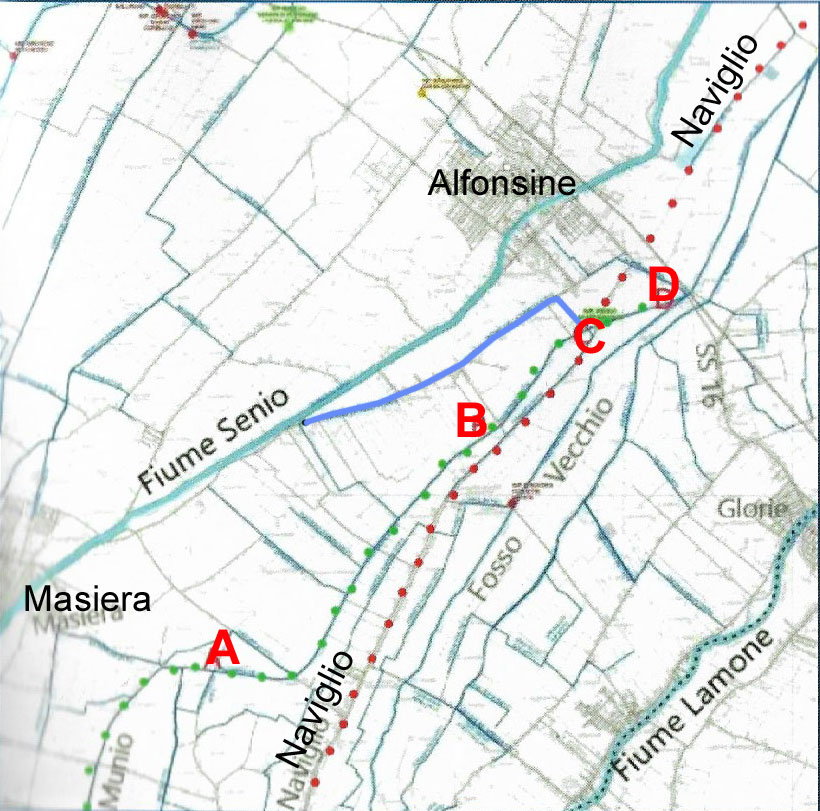
Punteggiato in verde il corso finale del Fosso Munio; in rosso il corso del Canale Naviglio.
A: incrocio di Via Stradello con Via Sinistra Fosso Munio;
B: incrocio con Via Bastogi;
C: sotterranea tra Naviglio e Fosso Munio;
D. confluenza del Fosso Munio col Fosso Vecchio.
Prima di incrociare il Canale Naviglio il Fosso Munio riceve tutti i canali di scolo della zona Rossetta alla sua sinistra
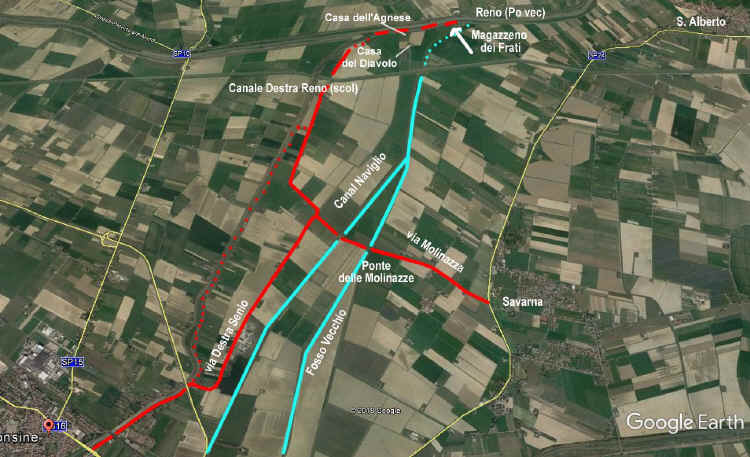


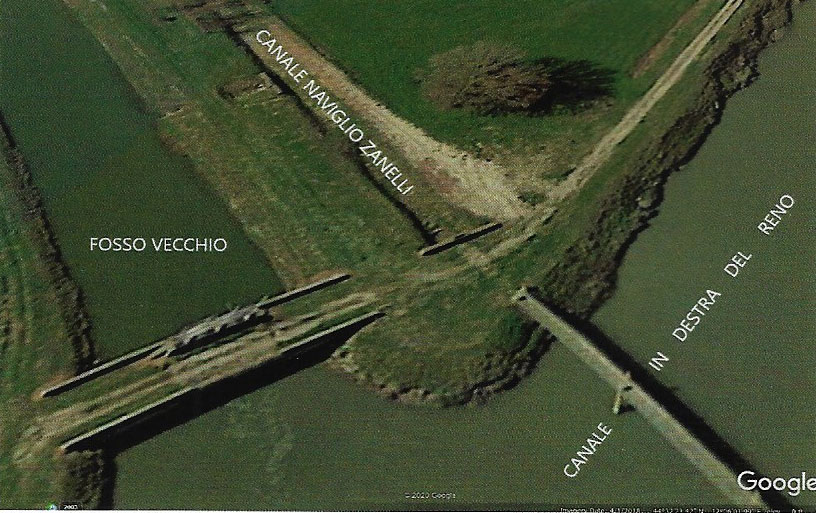
Un
Mulino alla fine del Canale Naviglio
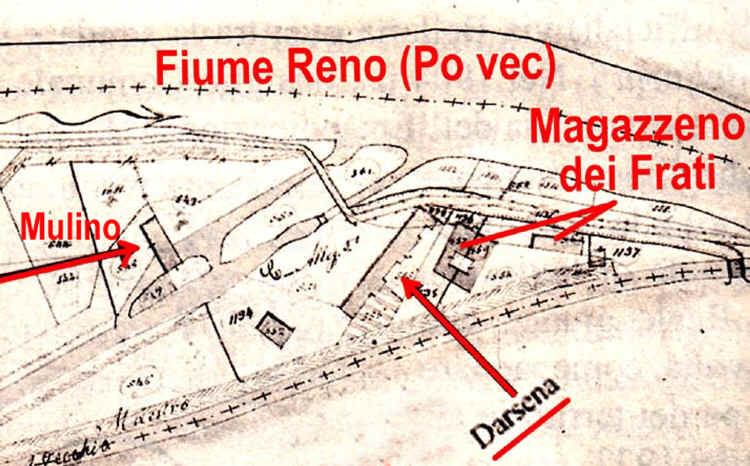
La
mappa del catasto napoleonico del 1807-08,
qui sopra riprodotta, mostra
che in questa parte finale del Canal Naviglio che c’era un mulino e
per questo il canale prendeva qui anche il nome di "Canale del Molino".
Subito dopo c'era una specie di darsena per barche, e due edifici che erano
probabilmente i vecchi magazzini dei frati di S. Maria in Porto.
Fu realizzato
anche un oratorio dedicato all’Immacolata Concezione, che andò distrutto con la
seconda guerra mondiale.

Nella
foto sopra i ruderi dell'antico oratorio al Magazzeno,
conservati presso due case
private
Per
giungere a questo molino da Alfonsine si percorreva a tratti l’argine destro
del Senio e quando c’erano piogge diventava impercorribile.
Vi erano diverse
carraie per arrivare all’argine del Reno, e nel 1867 si fecero lavori per
sistemarne alcune.
Ad
Alfonsine allo
sbocco del Canale Naviglio nel Po di Primaro era stato realizzato un oratorio
Alla
foce col Po di Primaro (poi Reno)
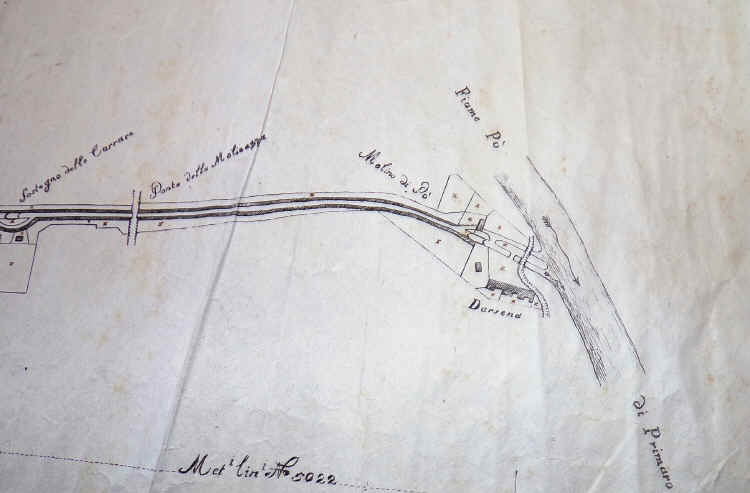
Nella mappa qui sopra del 1838 si vede lo sbocco del canal Naviglio nel Po di Primaro in
località Magazzeno ad Alfonsine, con le scritte: "Darsena, Molino di Pò
e Ponte della Molinazza e Sostegno delle Carrare"
(un
click o un tocco sulla mappa per averne un ingrandimento)
Questo
molino era più importante di quanto si possa immaginare perché ancora nel
1878 serviva “moltissimo ad una gran parte del territorio alfonsinese a
destra del Senio – si legge in un documento del 1878 dell’Ing. Capo
del Genio Civile - e ad una gran parte del territorio di Ravenna
cioè alle ville di Mezzano Savarna e soprattutto Sant’Alberto.”
|