|

Un
libro sulla Settimana Rossa alfonsinese
Quando Alfonsine
divenne famosa
(scritto da Luciano Lucci)

|
| La
festa dello Statuto |
|
"Non
v'è dubbio che se Ancona fu il centro irradiante della Settimana Rossa,
Alfonsine ne rappresentò per molti aspetti l'apoteosi, il luogo insieme
fisico e simbolico, dove il miraggio rivoluzionario raggiunse il culmine,
rendendo il nome di questa piccola cittadina a nord ovest di Ravenna
celebre in tutta Italia" (da "Settimana Rossa e dintorni di
Alessandro Luparini)
|
|
La data del 7
giugno era quella in cui i monarchici celebravano
la festa dello Statuto. Da socialisti, anarchici e repubblicani è vissuta
come una ricorrenza di propaganda militarista.
Si
tenne un comizio in piazza Monti "pro Masetti", su iniziativa
degli anarchici locali, con l'adesione dei socialisti e dei repubblicani.
Intervennero Meschi, segretario della Camera del Lavoro di Carrara e Bacci,
segretario della Camera del Lavoro di Ravenna.
|
|
Analoghe
manifestazioni antimilitariste si tennero da vari mesi in varie parti d'Italia, contro le
Compagnie di Disciplina e per la liberazione delle vittime del militarismo:
Augusto Masetti e Antonio Moroni. Una grossa manifestazione fu attuata a Villa Rossa, sede
repubblicana di Ancona, dove parlò Pietro Nenni, allora dirigente
repubblicano, e Enrico Malatesta, vecchio storico esponente
dell'anarchismo italiano.
La
protesta fu contro la guerra di Libia e per l'abolizione delle Compagnie
di Disciplina nell'esercito, motivo per cui il soldato Masetti aveva
sparato a un suo superiore.
|
|
Ad
Ancona
(clicca
o tocca per
maggiori dettagli)
un comizio fissato
nella mattinata, che doveva svolgersi in Piazza del Papa, ma che era stato
proibito, dato che pioveva, venne spostato dai dirigenti dei partiti, al
pomeriggio alle 16, a Villa Rossa, sede dei repubblicani di Ancona.
Gli aderenti ai
partiti di estrema sinistra, repubblicani, anarchici, socialisti, si
trovarono alla Villa Rossa per ascoltare diversi oratori. Erano presenti in circa cinquecento,
in maggioranza anarchici e repubblicani.
Poco dopo le 18 il
comizio ebbe termine. All'uscita della gente si
formò una specie
di corteo. Molti volevano andare a manifestare in piazza Roma, dove si
teneva un concerto
militare. Sulla
strada c'erano carabinieri ed agenti che dovevano impedire il formarsi di
un eventuale corteo diretto al centro. Un gruppo di giovani tentò di passare.
Nell'inevitabile
scontro le pallottole dei carabinieri colpirono a morte tre giovani
lavoratori:
due
repubblicani Antonio Casaccia di 24 anni
e Nello Budini di 17 anni,
che morirono
all'ospedale, e l'anarchico Attilio Giambrignani, di 22 anni, morto sul
colpo.
Episodi tragici di questo tipo erano
accaduti sovente in quegli anni. Quello
di Ancona fu la goccia che fece
traboccare il vaso.
|
|
La
notizia arriverà solo con i giornali del mattino seguente
|
|
I
soldati dell'esercito regio di presidio ad Alfonsine non ebbero alcun motivo di
intervenire.
|
|
|
Comizio
per Masetti:
chi era?
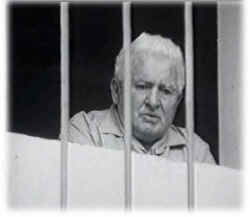
|
| Contro
manifestazione
ad Ancona a Villa Rossa di repubblicani, anarchici e socialisti |
| Contro
la guerra di Libia e le Compagnie di Disciplina |
| Ad
Ancona i carabinieri sparano sulla folla: 3 morti |
| Ad
Alfonsine la notizia arriverà il giorno seguente |
| La
serata ad Alfonsine è calma |
|
Lunedì
8 giugno 1914 |
| La
notizia viene appresa dai giornali |
Quando
le masse popolari alfonsinesi lessero sui giornali cosa era successo ad
Ancona si diffuse commozione ed ira. I partiti si riunirono a attesero
indicazioni da Ravenna.
|
| Sciopero
generale per il giorno dopo |
A
Forlì, Ravenna, Cesena, Faenza, Fabriano, Falconara, Senigallia e in
altre città e paesi delle Marche e della Romagna, come pure Roma,
Firenze, Milano e Napoli operai e masse popolari entrarono in agitazione e
proclamarono lo sciopero generale per il giorno 9, a cui si accoderà la
dirigenza nazionale della Confederazione del Lavoro e le Direzioni
Centrali dei Partiti Repubblicano e Socialista.
|
| Bandiere
a mezz'asta abbrunate. |
In paese c'era calma totale, ma era solo apparente. Furono esposte bandiere
a mezz'asta abbrunate, nelle sedi dei partiti, e anche nel Municipio.
|
| Calma
apparente in paese |
Alla sera, vista la calma il plotone di fanteria partì verso la ferrovia.
|
| Primo
assembramento di folla in piazza Monti |
Mattino:
Ad Alfonsine, come in altri paesi e città della Romagna, diffusasi la
notizia dei gravi fatti di Ancona e della mobilitazione generale, si
costituì un Comitato Rivoluzionario di socialisti, anarchici,
repubblicani e sindacalisti che organizzò la protesta e aderì allo
sciopero nazionale indetto dalla Confederazione Generale del Lavoro.
Fu pubblicato un
manifesto - come scrive Alessandro Luparini su "Settimana Rossa e
dintorni"- della Camera del Lavoro repubblicana firmato da segretario
Ferruccio Mossotti, in cui si esortava tutti i partiti popolari a
coalizzarsi contro "il rifiorire delle novantottesche aberrazioni
reazionarie" ed a levare un "severo monito ai violentatori della
libertà" (La minuta di questo manifesto datata Alfonsine, 9 giugno
1914, si trova nelle carte dell'Avv. Mario Ricci, oggi di proprietà del
sig. Giovanni Valentinotti. In copia presso AISREC).
Con suono di corni, fu chiamato
tutto il popolo in piazza Monti.
Dopo
brevi discorsi e fu preparato un apposito palco per gli oratori.
Verso mezzogiorno
un gruppo di rivoltosi anarchici lanciò slogan per incendiare municipio e
chiesa, qualcuno scrisse sul muro del circolo monarchico “Viva Masetti,
abbasso l’esercito”.
Poi essendo
mezzogiorno in punto, ora di andare a pranzo, l'esortazione a non
commettere vandalismi, fatta da alcuni membri del Comitato Rivoluzionario
fu ascoltata:
il pranzo ad Alfonsine è sacro!
Tutto proseguì
lietamente nel primo pomeriggio.
|
| Comizio
di Mossotti e Garavini
Prima
penetrazione nella chiesa 
Don
Serafino Servidei col cappellano Antonio Pattuelli (Patvél)

"Brasulina", dopo
qualche anno
dalla "Settimana Rossa" soldato
nella 1° guerra mondiale.

Il barbiere "Brasulina" davanti al negozio in piazza Monti
|
Alle
17 un inconsueto suono delle campane annunciò il comizio.
Pomeriggio:
In Piazza Monti si tenne un comizio, organizzato dai socialisti in
cui parlarono Ferruccio Mossotti di Alfonsine, segretario della Camera
Gialla (repubblicani) e il sindaco di Alfonsine Camillo
Garavini, socialista.
Il comizio fu annunciato col suono delle campane.
Infatti un gruppo di manifestanti di tutti i partiti, ma "in
prevalenza anarchici" (dalle memorie del parroco don Tellarini)
entrò nel cortile della canonica.
Alcuni anarchici
erano entrati in chiesa, sfondando la porta della sacrestia.
"Penetrati da
lì nel campanile suonano le campane, nonostante che anche il sindaco
tenti di allontanarli" (relazione della Pubblica Sicurezza).
Pare che stessero
anche per strappare il grande Crocefisso appeso al muro, quando il pianto
disperato di alcuni bambini presenti li fece desistere.

Il
piazzale della chiesa, com'era all'epoca in cui avvennero alcuni degli
episodi descritti nel diario del parroco Don Luigi Tellarini
Il cappellano
Don Mario Bonetti, in seguito a una discussione con alcuni del gruppo, si
prese uno scapaccione e una spinta violenta che lo scaraventò in mezzo al
cortile.
L'altro
cappellano don Serafino Servidei fu colpito, a suo dire, da una pietra lanciatagli
contro da Alfredo Ballardini, barbiere, detto “brasulina”, che gli
produsse la rottura di una costola, secondo il referto del dott. Pasini
che lo visitò all'ospedale.
Gli atti processuali documentarono che fu un
altro, e non "Brasulina", a lanciare quel sasso.
|
| Nel
comizio si usano parole di fuoco per incitare gli animi |
In
piazza le parole degli oratori incendiarono gli animi.
Le parole
degli oratori tendevano a scaldare gli animi, secondo la filosofia del
socialismo massimalista del tempo: sparare alto a parole e frenare nei
fatti.
Dalla sintesi
del rapporto del colonnello dell'esercito si legge:
"incitamento alla guerra civile, vilipendio delle istituzioni,
istigazione a delinquere".
|
| Corteo
per Corso Garibaldi |
Finito
il comizio si formò un corteo lungo Corso
Garibaldi, in testa i repubblicani con Ferruccio Mossotti (alfonsinese e
segretario della Camera Gialla), poi i socialisti col sindaco. Arrivati al
ponte sulla via Reale, alcuni cercarono di spingere il corteo verso la
Stazione, ma i socialisti tornarono verso la piazza, tirandosi dietro
tutti gli altri. |
| Nuovo
comizio e invito all'indomani a manifestare a Ravenna |
In
piazza di nuovo sul palco
salì il Mossotti che
terminò il comizio invitando tutti anarchici, repubblicani e socialisti
per il giorno dopo il 10 giugno alle ore 9 a Ravenna, dove si sarebbe
tenuta una grande manifestazione.
Il sindaco dal
palco confermò l'invito del Mossotti. |
| 10.000
manifestanti a Ravenna |
La
mattinata scorreva tranquilla, perché in molti
erano andati a Ravenna.
I negozi erano
aperti. Anche il sindaco era a Ravenna e sarebbe tornato alle 11,30.
In chiesa fervevano
i preparativi per la solenne processione del Corpus Domini che in
quell'anno cadeva l'11 di giugno.
La chiesa era
addobbata con i paramenti più belli e ricchi: tovaglie con pizzi ricamati
in oro e seta dalle suore di
S. Chiara di Faenza, baldacchino pure di seta e oro, argenterie ecc... |
| Primi
scontri a Ravenna... |
A
Ravenna confluirono in bicicletta, sui carri dei birocciai e su altri
mezzi, più di 10.000 lavoratori, per lo più braccianti e mezzadri di
fuori Ravenna. Parlarono esponenti della Camera del Lavoro, socialisti,
repubblicani e anarchici. |
| ...
davanti alla Prefettura

Muore,
colpito alla testa da una bottigliata, un commissario di Pubblica
Sicurezza |
Al
termine del comizio, gli scioperanti si portarono in massa in piazza del
Popolo davanti alla Prefettura. Qui accaddero i primi scontri con le forze
dell'ordine. |
| Un
commissario di Pubblica Sicurezza e un colonnello dei Carabinieri furono
colpiti con bottiglie di vetro e bastoni. Giuseppe Miniagio, il
commissario, colpito alla testa da una bottiglia di seltz, morì dopo
qualche giorno. In tutta
Ravenna i soldati erano poco più di 300. In quell'occasione il tenente
alla guida dei carabinieri non diede ordine di aprire il fuoco. |
| Qualche
devastazione e piccoli scontri |
Ci
fu qualche scorribanda per le vie del centro di Ravenna, con alzata di
barricate qua e là, devastazione di due chiese: alcuni mobili furono bruciati
nella piazza, furono tagliate le linee telegrafiche, e ci fu da parte
dell’esercito una scarica di 80 colpi di fucile contro la Casa del
Popolo repubblicana.
Alla sera la
tensione calò. |
| Raduno
di folla ad Alfonsine |
Ad
Alfonsine, alle ore 16, la folla, comprese donne
delle varie leghe e i bambini vocianti, si radunò in piazza Monti.
Il suono dei
corni ne diede l'annuncio.
|
| Il
Comitato rivoluzionario |
Il
Comitato rivoluzionario si presentò come un gruppo serrato al centro della piazza. A
capo c'era il sindaco Garavini (secondo quanto scrive il parroco) |
|

Bruto Marini

Il Circolo Monarchico
distrutto: a terra i resti del bigliardo. Sul muro le scritte
"W Masetti" "M l'esercito".
A sinistra il manipolo di carabinieri di Alfonsine e a destra alfonsinesi in
posa, forse gli stessi della rivolta.
Quel
palazzo fu acquistato poi da Tancredi Minarelli detto Plopi, anarchico,
che lo adibì deposito del suo carro funebre, a stallatico e a monta per
cavalli.
Ai piani superiori creò camere da affittare a gente povera.
Giuseppe
Marini acquistò nei primi anni '30 da Plopi l'edificio, per usarlo come fabbrica
per la produzione delle sue biciclette, poi delle moto "Marini"
e infine delle macchine stradali. La dicitura "Palazzo
Marini" è un'invenzione degli anni 2000, cioè da quando si è
sentito parlare di "donazione". Infatti
recentemente (2004) l'edificio è stato donato al Comune, dai
proprietari Fayat, ristrutturato, e adibito a
un centro culturale.
|
Una
voce incontrollata:
"C'è la rivoluzione!"
Non
era vero,
però... ci vollero credere
Un ricco
proprietario terriero di Alfonsine, il cav. Bruto Marini, che viveva a
Roma dove aveva ottenuto la gestione del trasporto pubblico della città
coi tram trainati da cavalli, era appena arrivato ad Alfonsine la notte
precedente con tutta la famiglia. Aveva viaggiato con la sua De Dion Buton,
la prima auto apparsa in paese.

L’auto
De Dion Buton dei Marini in una foto di due anni prima, del 1912, nel
parco della loro Villa di Alfonsine, con due dipendenti alfonsinesi
(Malvina e Nando Troncossi)
Qualcuno
andò in giro a raccontare che fossero fuggiti da Roma perché era
scoppiata la rivoluzione. Tanto bastò perché girasse la voce che il Re e
la Regina erano fuggiti e che la Monarchia era caduta. Gli alfonsinesi non
ci pensarono due volte (forse per paura di svegliarsi dal sogno).
La
voce, incontrollata e non vera, della caduta del Re e della nascita della
Repubblica si diffuse tra tutta la popolazione e nei paesi vicini, che
decisero di fare come quelli di Alfonsine.
“Furono
sbarrate le vie – racconta il parroco Don Tellarini – con
grosse catene e in capo ad ogni via stavano due guardie rivoluzionarie col
fucile alla spalla con ordine di intimare « alto là » a chiunque non
avesse il lasciapassare del Comitato. Il sacrestano della chiesa,
Patuelli Antonio, ottenne anch'egli il suo lasciapassare che io stesso –
continua don Tellarini – ebbi in mano e
che era così concepito: «Si rilascia il seguente lasciapassare al sig.
Antonio Patuelli perché non sia toccato nella sua roba e nella sua
famiglia. Firmato: il Comitato rivoluzionario », e seguivano i nomi.”
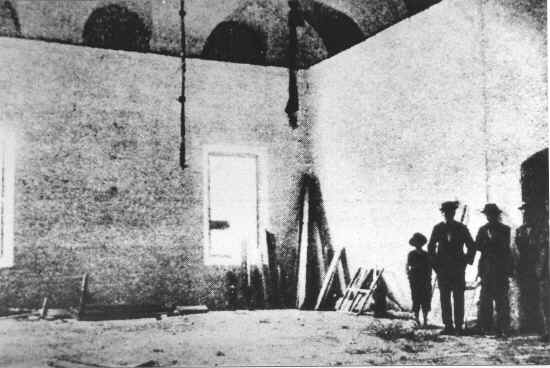
Circolo
Monarchico di Alfonsine
(Interno)
dopo l'assalto
|
| Il
comizio

Il
municipio di Alfonsine e la piazza Monti dove si radunò la folla per i
comizi durante la Settimana Rossa

|
Alle
17,30
Al
comizio in Piazza Monti dovevano parlare il sindaco e
Ferruccio Mossotti. Correva voce che a Ravenna stava scoppiando la
rivoluzione.
All'entrata
del Palazzo Municipale, dove era stato eretto in precedenza un palco,
iniziarono a parlare gli oratori.
Il
primo fu il sindaco Garavini che, da navigato comiziante, arringò la
folla (queste parole furono la testimonianza lasciata dal parroco che
stava origliando da dietro le persiane della canonica e sono probabilmente
state esagerate ad arte per mettere in cattiva luce il sindaco e gli altri
organizzatori delle manifestazioni):
"Compagni!
Lavoratori! Finalmente Vittorio Emanuele è caduto! Finalmente è caduto
l'odiato governo della borghesia! Finalmente comandiamo noi! Siamo noi ora
i padroni della situazione e del governo! Andate nelle case e tirate in
petto alla borghesia ecc... ”
Queste
parole sentite da Don Tellarini, nel loro contesto vero suonano in altro
modo.
In
un memoriale d'autodifesa, il Garavini scrisse di quell'esortazione
rivolta ai manifestanti durante il comizio pomeridiano del 9 giugno, che
era di non approfittare della circostanza (perché lo sciopero generale
era "il solo giorno che passa"), ma a "colpire in
pieno petto la borghesia coll'unità proletaria e colla solidarietà",
per mezzo delle organizzazioni economiche e del suffragio universale.
Poi
intervenne Mossotti.
Secondo
testimonianze di parte (il pretore, il sig. Anselmo Alberani e il parroco
Don Tellarini avrebbero udito con le loro orecchie), i due avrebbero
incitato alla distruzione e alla devastazione:
altre
frasi che avrebbero sentito erano
-
Tutti compatti: chi è con noi e contro di noi lo
conosceremo domani. I padroni siete voi, fate quello che volete –
armatevi (Mossotti)
-
"Prendete da tutti ciò che volete"
(un anarchico)
-
"No, solo dai borghesi, rispettate i
commercianti.
Il vostro nemico è la borghesia" (il sindaco)
Alcuni
anarchici avrebbero gridato "Abbasso il Tricolore!" che era
stato issato a mezz'asta lì sopra il Municipio per i fatti di Ancona.
Dalla folla
galvanizzata durante il comizio si sentì anche qualcuno gridare
"Viva
il Comunismo! Viva la rivoluzione”.
|
|

Assalto
alla stazione per interrompere le comunicazioni

Il Circolo
Monarchico di Alfonsine
distrutto: a terra i resti del bigliardo.
Sul muro le scritte
"W Masetti" "M l'esercito".
A sinistra il manipolo di carabinieri di Alfonsine con i loro cavalli a
controllare i danni subiti dal Circolo Monarchico, dopo i giorni caldi; a destra alfonsinesi in
posa, forse gli stessi della rivolta.
|
Ore
19
Terminato
il comizio, dalla
folla si udirono grida: "Bene! bene! Evviva la rivoluzione! Abbasso
la borghesia!" e poi "Alla stazione! Alla stazione!"
Si formò un
corteo spontaneo con alla testa gli anarchici (ma secondo la denuncia
della polizia "dirige il tutto Mossotti e, pare, anche il Sindaco")
che dalla piazza si avviò lungo Corso Garibaldi. Una specie di orda
selvaggia che questa volta arrivò alla stazione, saccheggiò da un
casetto alcune barre di ferro e divelse un tratto di ferrovia, oltre alla sistematica rottura dei fili di telegrafo
e telefono.
Sempre al
suono dei corni e alla luce delle torce a vento,
i manifestanti tornarono in Piazza Monti. La scena
doveva essere impressionante.
La folla si recò
poi al Circolo Monarchico (o Circolo Cittadino) che era lì a due passi
(oggi quel palazzo è detto "Palazzo Marini" ed è stato
ristrutturato e donato al Comune di Alfonsine).
“Sfondata
la porta (la descrizione è del parroco) con leve e grossi pali,
salirono nella sala superiore dove c'era un bigliardo e lo gettarono
intero dalla finestra. Volarono fuori le immagini del Re Vittorio Emanuele
III e della Regina d'Italia. Poi sedie, tavolini di marmo, bicchieri: si
vedevano i giovani afferrare bottiglie piene di liquori d'ogni colore e
sbatterle contro le colonne con battute ironiche e imprecazioni. L'aria
era satura di vapori alcolici. Cadendo al suolo il bigliardo si spaccò in
mille pezzi."
Oltre
all'aspetto distruttivo e rancoroso (furono
gettati dalla finestra del secondo piano del Circolo Monarchico un
biliardo, sedie e ogni suppellettile) qui troviamo anche l'aspetto ironico
e giocoso con la defenestrazione dei quadri del Re Vittorio Emanuele III e
della Regina: "Abbiamo buttato giù la monarchia" - gridò
qualcuno con quel pizzico di ironia tipica degli alfonsinesi quando
vogliono sdrammatizzare qualche evento.
Fu
questo uno dei tanti riti simbolici che segnarono molti aspetti della
rivolta, spesso oscillante tra il grottesco e il giocoso.
|
| Assalto
alla chiesa

La chiesa Santa Maria di
Alfonsine dopo il saccheggio
Si notano i
resti del falò. Gente di Alfonsine in posa per la foto. Nello sfondo la
locanda "Al Sole" di Fed (Bonafede Minarelli) e Susanna Garavini
(sorella del Sindaco). poco più avanti si intravvede la Bettola dei Cicconi
(e' betulè): una delle tante osterie della piazza di Alfonsine
|
20,30
Giovani
adolescenti scoprirono per la prima volta l'ebbrezza della festa
Per
una volta fuori dallo stato di necessità e miseria, anche i bambini e gli
adolescenti furono protagonisti, sempre in prima linea a godersi
l'ebbrezza della festa.
Arturo
d'la Canapira (n.1900 - m.2002), che allora aveva 14 anni, ha raccontato
che lui e una sua amichetta erano entrati dentro al Circolo Monarchico
durante il saccheggio.
Impossessatisi
di una bottiglia di liquore se la bevvero.
Il
parroco don Luigi Tellarini che stava guardando attraverso le persiane
chiuse della finestra della canonica così descrive la stessa scena:
"Si
vedevano i giovanetti, con un accanimento indescrivibile, afferrare
bottiglie piene di liquore d'ogni colore e sbatterle contro le colonne
della casa di fronte con gioia così pazza e con tale ironia che faceva
fremere d'orrore e l'aria era talmente satura di odore alcoolico da non
potersi descrivere."
Fu assalito
l’ufficio delle poste, poi anche quello del telegrafo e del telefono che
erano collocati al pian terreno, in alcune stanze del
Municipio.
L'assalto
alla chiesa
La folla si spostò poi nel piazzale della chiesa, preceduta da uno stuolo
di ragazzi festanti.
I manifestanti si
arrestarono davanti alla porta laterale della chiesa e iniziarono una
sassaiola contro i vetri della canonica. Con grossi pali un gruppo di
anarchici ne abbattè la porta: entrati gridarono "in
dov'el clu c'cmanda!" (dov'è quello che comanda?".
Passarono quindi in sacrestia e appiccarono il fuoco ovunque: tre grandi
armadi pieni di arredi sacri, il banco che serve ai sacerdoti per mettere
gli apparati, gli sgabelli, le porte, le panche e le statue.
In chiesa furono
incendiate le grosse porte esterne, i confessionali e un gran mucchio di
sedie (160), che appartenevano al sacrestano Antonio Pattuelli (Patvèl).
I banchi di noce
massiccio furono ammucchiati all'esterno, spaccati e fu fatto un gran falò.
Nel rogo finirono anche varie statue di legno:
il San Giuseppe e
il Sant'Antonio e l'Addolorata, opere degli antichi Graziani di Faenza,
poi la statua della Beata Vergine di Lourdes, San Francesco Saverio, la B.
V. del Rosario.
Gran parte della
gente assistette muta e stupefatta, in lontananza, ma nessuno osò fermare
il gruppo di devastatori, probabilmente anarchici, ma non solo.
Il sindaco accorse
davanti alla chiesa per esortare i più scatenati a non commettere tali
eccessi.
Poi fu trascinato
via da sua moglie e dall'assessore Dradi, che temettero per la sua
incolumità.
Il gran falò durò
parecchie ore: una folla festeggiava intorno cantando inni
rivoluzionari e anarchici. Si udirono frasi come "Viva la
rivoluzione sociale!", non solo dagli anarchici ma anche dai
repubblicani e dai socialisti.
|
| I
carabinieri restano chiusi in caserma

Caserma dei carabinieri
di Alfonsine in Corso Garibaldi
|
Il delegato di
Pubblica Sicurezza si era dato ammalato fin dal pomeriggio, fuggito nel
giardino del Dott. Filose medico condotto del centro. Questi lo trovò
sotto un albero in preda al panico, a febbre, a vomito... Il dottore lo
accompagnò all'ospedale dove fu colpito da dissenteria.
I Carabinieri a
cavallo erano in 13 e rimasero chiusi nella caserma in fondo al Corso
Garibaldi, con le porte barricate: il maresciallo, quando venne a sapere
dell'incendio della chiesa sarebbe voluto uscire.
Il dott. Filose lo
dissuase dicendogli "che era assurdo contrastare le migliaia di
persone intente alla distruzione".
ore 22
Alle 22 arrivò il
Pretore che guidò i carabinieri alla chiesa per aiutare i volontari a
spegnere l'incendio nella sacrestia,"mentre i facinorosi si
trovavano ancora in piazza attorno al falò"
Alle 23 il fuoco
ardeva ancora dentro la chiesa, in diversi punti, sul sagrato (e questo
era il rogo maggiore), in sacrestia e anche nel cortile interno.
Il parroco e la
sorella riuscirono a fuggire a casa del cappellano Don Serafino Servidei
che abitava a poche centinaia di metri metri.
Poi a mezzanotte il
parroco tornò e trovò gli stessi che avevano fatto quel disastro che si
offrirono di spegnerlo. Lui fece buon viso a cattivo gioco e per tenerseli
buoni offrì loro un fiasco di vino.
“Era di poco
passata la mezzanotte e quasi tutti se ne erano andati al riposo; pochi
restavano ancora i quali, appena mi videro e certi di essere da me
riconosciuti, vigliaccamente si profersero di fare opera di spegnimento,
mentre poi essi medesimi erano di quelli che dianzi avevano appiccato il
fuoco. Ricordo benissimo che io, sia perché li ritenni veritieri, sia per
cattivarmi l'animo loro, ebbi il pensiero di offrire loro alcuni fiaschi
del mio vino migliore. All'una erano tutti a dormire."
Ma il parroco sentì
ancora qualcuno che si avvicina al campanile, deciso a suonare le campane:
“Poco dopo, nel cupo silenzio, interrotto soltanto dal continuo
abbaiare dei cani, scorgo altre due ombre avanzarsi verso la Canonica: non
fui capace di riconoscerli... Andiamo sul campanile, dice l'uno di essi,
andiamo a suonare il campanone. Mi corse un brivido per le vene. Mi
precipito allora ad avvertire la sorella che era andata a riposare,
prevenendola ed assicurandola a non aver paura: era tanto terrorizzata! E
le campane cominciano a suonare nella notte triste e lugubre, non già per
invitare i fedeli alla preghiera e al sacro tempio, ma per avvertire che i
rivoluzionari erano essi padroni del campo!!” |
|
| Nuovo
assalto alla chiesa

Chiesa Santa Maria di
Alfonsine
Questa è
l'ancona (tabernacolo in legno) al centro dell'altare su cui era incastonata
la ceramica della Madonna delle Grazie.

Ceramica della Madonna delle Grazie di Alfonsine
Questa è
una ceramica del '500 ancora esposta nell'attuale chiesa parrocchiale Santa
Maria di Alfonsine. Durante la Settimana Rossa subì alcuni spari nel
tentativo di distruzione da parte dei manifestanti. I colpi lasciarono
alcuni segni ancora visibili, ma il quadro non si ruppe. Questo fatto
divenne una leggenda alfonsinese.
Il
quadro superò anche la distruzione totale della chiesa avvenuta durante la
seconda guerra mondiale.

Chiesa Santa Maria di
Alfonsine
(fototeca
Archivio Istituto Storico della Resistenza di Alfonsine)
Interno
della chiesa prima del saccheggio della Settimana Rossa. Si
notano i lunotti con vetrate da cui arrivava la luce

L'immagine di S.
Andrea,
da
un quadretto di un'altra chiesa italiana

E betulè
La bettola dei Minguzzi
(detta dei Ciconi). Si tratta di un chiosco-osteria della famiglia
Minguzzi, posto di fianco alla chiesa.


Qui
sopra la foto di
Antonio Minguzzi
uno dei figli di Ciconi. All'epoca dei fatti era il bambino dodicenne
di cui parla don Tellarini. Sarà poi il babbo della maestra Maddalena
Minguzzi.

Il
caffé degli anarchici detto “dla Niculéna”
|
E’
il giorno del nuovo assalto alla Chiesa Santa Maria: ateismo, spirito
pagano e superstizione, bambini festanti in prima fila, donne danzanti con
i vestiti del prete.
Al di là della violenza e della furia sacrilega di qualcuno,
ci fu anche la magia di un carnevale fuori stagione e tutto da
inventare.
Ore 4
I
prodigi della S.S. Vergine Maria
Sopra l'ancona (tabernacolo in legno) del coro, ad un’altezza
di circa cinque metri, circondata da una bella cornice, era collocato un
quadretto di terracotta raffigurante la B. V. delle Grazie col Bambino.
I rivoluzionari che erano saliti sui gradini dell'altar maggiore,
cominciarono a tirare colpi di sasso contro l'immagine: il quadretto,
appeso ad un cordoncino, dondolava, ma non si spezzava: non cadde.
I colpi
lasciarono alcuni segni ancora visibili.
Luigi
Tazzari, conosciuto con il soprannome di Gigiò d'Mignac, componente della
banda comunale e del coro nelle Funzioni religiose entrò in chiesa,
deciso; la nicchia era troppo in alto per potervi arrivare. Gli venne
un'idea: andò nella adiacente casa del sagrestano, Patvel, si fece dare
un tavolino, vi salì, ma non bastava; pensò allora di mettere su quello
una scala, non bastava ancora; ne mise un'altra, aiutato dal sagrestano
stesso e dall' amico Domenico Pirazzini, Minghì d' Stasiol; le si avvicinò
di più, in modo già sufficiente per poterla afferrare e, con grande
sforzo, pur rompendo il nastro che la decorava, riuscì a rimuoverla e
portarsela via.
Il
Parroco stesso, Don Tellarini, alquanto spaventato, lo aveva esortato
insistentemente a non rischiare. Incolume, Gigiò scese dalla scala,
nascose tutto sotto la camicia e, munito di un grosso bastone per
difendersi da eventuali assalitori, si incamminò per Via Borse. Presso la
casa Gessi fu bloccato da gente armata, ma lui riuscì a cavarsela,
arrivare in Via Stroppata, all'abitazione di Don Michele Pirazzini,
informarlo che la chiesa stava bruciando e consegnargli il suo prezioso
tesoro. Erano le quattro del mattino di quel memorabile 11 giugno del
1914. Virtù e forza di una grande fede che Gigiò conservò sempre. Alla
sua morte, oltre al bocchino del trombone, il fedele amico per quarantadue
anni, sul petto volle una immagine della "sua" Madonna. Così ha
raccontato la figlia Augusta.
Questo
fatto divenne una leggenda alfonsinese
Questa storia raccontata dal parroco diventò di dominio pubblico e fu
trasmessa di generazione in generazione, alimentando così una vera e
propria leggenda alfonsinese.


Un’altra
leggenda, legata a quei giorni, riguardò una donna
che, durante il saccheggio della chiesa, si mise davanti al quadro della
B. V. delle Grazie col Bambino e chiese di avere un segnale dell’esistenza
della Madonna. Quella donna era incinta: pochi mesi dopo le nacque una
figlia che era priva del braccio sinistro, tanto che fu soprannominata
dagli alfonsinesi “la moncaréna”.
Ore 7
Fin dal
mattino ripresero gli atti vandalici contro la chiesa.
Fu
distrutto l'organo della ditta Strozzi di Ferrara, che era fatto di 800
canne in stagno nella facciata, e altre di piombo e di zinco.
Un
gruppo dei più esagitati scaraventò di nuovo sulla piazza altre panche,
statue e suppellettili per alimentare un nuovo falò. Non tutta la
popolazione li seguì, ma non erano certamente in pochi; ad Alfonsine gli
anarchici erano un numero considerevole; ad essi si unirono anche i “mazziniani
intransigenti” e i socialisti rivoluzionari.
Durante
il saccheggio della chiesa si videro donne, uomini e ragazzi inscenare una
festa zingara con danze e musiche davanti al falò.
Molti
ragazzi si vestirono con camici, cotte e stole, e le donne con tovaglie da
altare e biancheria d'ogni sorta.
Poi tutti
a ballare nella festa dionisiaca davanti al fuoco alimentato con le
suppellettili e le statue della chiesa.
Li
accompagnava una musica tribale suonata con le canne dell'organo.
Infatti
dopo aver distrutto l'organo della chiesa, i saccheggiatori avevano tolto
dal loro posto le magnifiche canne di stagno, di piombo e di zinco (in
tutto circa 800);
poi le avevano date ai bambini della piazza che le fecero suonare
soffiandoci dentro.
 ‘Suonando
a tutto fiato- così descrisse la scena don Tellarini - corrono
nella piazza e incomincia allora quella musica barbara, quella nenia che i
poveri Selvaggi dell'Africa sogliono fare durante le loro feste
cannibalesche’ ‘Suonando
a tutto fiato- così descrisse la scena don Tellarini - corrono
nella piazza e incomincia allora quella musica barbara, quella nenia che i
poveri Selvaggi dell'Africa sogliono fare durante le loro feste
cannibalesche’
"E
malet da j azident" di S. Andrea
Uno dei
saccheggiatori stava tentando di colpire l'immagine di S. Andrea, per
spezzarla e distruggerla: un quadretto di legno scolpito che ritraeva il
santo cappuccino in atteggiamento devoto, con la corona in mano e la
bisaccia che gli pendeva davanti e di dietro a mo' dei frati questuanti.
A forza di colpi
contro il quadretto appeso al muro, stava per tirarlo giù, quando arrivò
di gran corsa un compagno il quale, con fare disperato, gli disse:
Ma cosa fai? -
Che faccio? - rispose l'altro meravigliato.
Ma non vedi che
è S. Andrea? Se S. Andrea apre il sacchetto degli accidenti, non
siamo rovinati?
(Il dialogo avvenne
in romagnolo: Se sant'Indrei l'arves e malet da i azident, an sen arvinée?).
Così il quadro di S. Andrea, a cui la credenza popolare attribuiva da
sempre facoltà iettatorie, si salvò; ma solo fino al 1945, quando la
vecchia chiesa andò distrutta con la guerra, e tutto l'arredo fu perduto
per sempre.
Furono però
spezzati i candelieri, il battistero e l'altare; bruciati gli arredi
sacri, rotte le cassette delle elemosine.
Fu forzata la porta
di casa del parroco e rubata l'argenteria, l'ostensorio, l'archivio, abiti
e una cassa di candele.
Armati di pistole e
fucili spezzarono tutti i vetri (circa 300) del coro, dei lunettoni e del
teatro parrocchiale.
Il saccheggio
continuò per tutta la mattinata.
Il parroco si era
rifugiato a Fusignano, dai suoi famigliari: “Ricordo che
nell'allontanarmi dalla piazza, passando avanti alla bettola dei Minguzzi
(detta dei Ciconi), uno dei figli, Antonio, mi seguì per spiare ove
andavo a rifugiarmi ed io dovetti fare parecchi giri e parecchie svolte
per fargli perdere le mie traccie. Come infatti così avvenne”.
Il
parroco tornò ad Alfonsine:
“Mi
premeva assai constatare quale sorte avevano corso le mie personali
suppellettili di casa e infatti solo, solo mi avviai verso la piazza. In
prossimità delle scuole comunali vidi venirmi incontro il capo dei
rivoluzionari, Mossotti Ferruccio.
Era rosso in viso, aveva gli occhi fuori
dell'orbita che sprigionavano scintille di fuoco, procedeva dondolando la
sua persona a destra e a sinistra: l'ho ancora presente alla mente: si
fermò, mi diede una terribile occhiata e passò oltre.
Giunto che fui presso il Caffé degli anarchici, detto il Caffé della
Nicolina, scorsi una moltitudine di persone che stava
ai tavolini a godersi il fresco, ed a contemplare la scena sorbendo il
caffé e centellinando bicchierini di liquori
con un'allegria indescrivibile.
Appena
mi videro fecero un gesto di sorpresa e ricordo uno che disse: Bé! non è
mica fuggito! Ma se è ancora qui!, e tutti gli occhi si appuntarono su di
me.
Io
tirai innanzi per la mia strada”.
|
| Assalto
alla pretura e incendio del Municipio


15 giugno: il
municipio di Alfonsine incendiato
(fototeca Archivio Istituto Storico della
Resistenza di Alfonsine)
Si vede che
è stato tolto l'orologio del municipio in alto.
La
foto fu pubblicata sul Resto del Carlino del 17 giugno 1914
|
Ore
8,30
Alcuni
dei più esagitati decisero di assaltare la sede della Pretura, che si
trovava in un locale al piano terra del Municipio.
In
quei giorni, l'Amministrazione Comunale socialista aveva deciso di avviare
lavori per un ingrandimento del Palazzo Municipale: ciò perché con il
nuovo sistema elettorale i consiglieri erano passati da 23 a 30 e non
c'era più spazio nella vecchia sala consiliare.
Di
fianco al Municipio c’erano le impalcature dei muratori per erigere il
fabbricato. Usando alcuni di quegli attrezzi fu sfondata la porta della
pretura e incendiati tutti i documenti. Poi l’incendio diminuì e si
spense lentamente.
Il
sindaco Camillo Garavini si trovava al Circolo Socialista, di là
dall’argine del Senio, con gli altri assessori lì riuniti per decidere
cosa fare nelle giornate successive: la linea fu di lasciar fare oppure
sarebbe stata guerra civile
(era questa la vecchia strategia di
Giolitti), ma qui indica
che i dirigenti socialisti erano assolutamente contro ciò che la massa
della gente stava determinando. Quando seppero dell'incendio si recarono tutti in
piazza.
Garavini
scrisse una lettera a Giovanni Bacci, che era a Ravenna: il messaggio
venne affidato ad un giovane ciclista, il quale fu fermato a Porta San
Biagio dai soldati (si ricordi che Ravenna si trovava in stato d'assedio)
e non poté portare a compimento la propria ambasciata. Questo il testo:
"Caro
Bacci, qui imperversa la violenza della folla contro le cose. Temo che
degenererà contro le persone. La chiesa e il municipio vennero
incendiati, la situazione più che grave è disperata. Noi facciamo del
nostro meglio, siamo fra la massa, ma oramai il movimento è
irrefrenabile. Prima di sera sarebbe indispensabile la tua presenza e
quella di [Umberto] Bianchi per tentare di pervenire l'incognita di questa
notte" (Carte Ricci, "Lettera di Camillo Garavini a Giovanni
Bacci [ma Alfonsine], s.d. [ma 11 giugno 1914]. In copia presso l'AISREC.
Questa appare anche su un articolo del 24 giugno 1914 del "Giornale
del Mattino" dal titolo "I 'misteri' di Alfonsine e le accuse
del'Carlino"
I dirigenti socialisti alfonsinesi furono quindi
assolutamente contrari a ciò che la massa della gente stava determinando.
La
vicenda di Garavini è emblematica come quella di tanti altri dirigenti
politici e sindacali, socialisti e repubblicani: per quanto moderati, si
lasciarono contagiare, almeno in un primo momento, dall'esaltazione
rivoluzionaria, finendo poi per restare soggiogati dagli avvenimenti.
|
| Il
sindaco si dichiara impotente a controllare la folla
|
Lì
il dottor Filose si avvicinò al sindaco e gli disse
- "Questa è anarchia!"
Al
che il Garavini rispose: - "Non ho più alcuna autorità per
trattenere la folla".
Il
signor Bruto Marini (Maré) e il signor Monti chiesero al sindaco: - “Perché
non impedite tutto questo?", ma non ebbero risposta.
Poi
Garavini si rivolse alla gente gridando loro:
-
"Se c'è la rivoluzione abbiamo vinto: non fate altri vandalismi!" |
| Assalto
alle case private
....
dai Marini

Bruto Marini |
ore
10
Altri nuclei
di rivoltosi capitanati da Mossotti si recarono nelle abitazioni dei più
ricchi del paese e sequestrarono beni alimentari, a volte con
l'intimidazione delle armi.
A casa di
Violani, (Pasaré) il mugnaio, sequestrano 98 quintali di farina. Presero
“in prestito” anche l'automobile con cui il Mossotti si sposterà poi
da un punto all'altro del paese.
Andarono poi
alla Villa di Maré, antico palazzo in Corso Garibaldi dove alloggiava il
sig. cav. Bruto Marini e il suo fattore Luigiò (Luigi Randi). Quando i
rivoltosi arrivarono, il Marini non oppose resistenza, ma ordinò ai suoi
dipendenti di spalancare le porte e ricevere a braccia conserte. Lasciò
prendere un po' di vino qualche sacco di farina. Pare che prelevassero al
fattore Luigi Randi i denari che aveva in tasca e l'orologio, ma non
recarono danni. (I Marini dopo quell’esperienza vendettero tutte le loro
proprietà: 48 poderi più la villa e la cantina).

|
| ...
dai Massaroli |
Si
recarono alla villa dei Massaroli nei Sabbioni alla sinistra del Senio,
(la Villa della Marchesa Giuditta Gallerani Passeri in Massaroli) che sarà
poi, nel dopoguerra, adibita ad Asilo Parrocchiale e poi abbattuta e
trasformata in un condominio negli anni ’70). Qui furono lasciati
entrare. Ottennero del denaro e se ne andarono senza fare
danni.
|
| ...
dagli Alberani

|
"As
cavarèn la fàm
/ cun la pignata d'j Alberàn"
Alla casa della famiglia del Dott. Anselmo Alberani, uno
dei più ricchi proprietari terrieri di Alfonsine, in via Reale (dove oggi
c’è la fabbrica di trasformazione “Contarini”) un gruppo guidato
dal capo degli anarchici locali, armato di mannaia, mazze di ferro e
bastoni scavalcò il cancello e fracassò tutto per entrare.
Ad
Anselmo Alberani fu puntata una pistola al petto e, sopra il suo capo, un
giovane teneva sospesa un'accetta, (secondo la testimonianza dello
stesso Alberani, quindi di parte).
Fu
perquisito, gli furono tolti i denari, fracassati tutti i mobili della
casa, specialmente quelli della stanza matrimoniale. Requisirono tutto ciò
che era commestibile.
Portarono
via un gran pentolone che stava sulla tavola imbandita per il pranzo, e
come trofeo lo portarono alla testa del corteo, di ritorno lungo “e
stradò”, ritmando in coro:
"As
cavarèn la fàm cun la pignata d'j Alberàn".
(testimonianza
Filippina Tamburini, su racconti della nonna)
I
ragazzini festanti precedevano la folla, rendendo almeno un po’ più
giocosa e allegra la festa della rivoluzione.
|
| ...
da Violani |
A
casa di Violani, il mugnaio, sequestrarono 98 quintali di farina marca 2°.
Presero anche l'automobile, con cui il Mossotti si sposterà da un punto
all'altro del paese |
| ...
dai Mingazzi |
Andarono
dai Mingazzi, dove vennero sequestrati 45 quintali di grano, vino e
denari. Fecero molti danni. |
| ...
dai Faggioli |
Da
Faggioli asportarono 30 quintali di grano. |
| ...
da vari bottegai |
Da
bottegai come la sig. Carolina Mirri, sul ponte nuovo, presero salami e
prosciutti, da Antonio Ricci requisirono armi, benzina, cartucce per
pistole e fucili, dal ramaio Grazioli, in piazza Monti, presero tutte le
catene di ferro che servirono per sbarrare le strade. A tutti dicevano di
mettere nel conto del Comitato e del nuovo governo. |
|
I
magazzini del popolo

Alla
sinistra del Municipio si vede il foro annonario, dove vi erano anche
magazzini del comune, oltre a negozi affittati ai privati

La
lapide a ricordo dell'Albero della Libertà del 1849.
(Il
punto esatto è davanti al ristorante-albergo "Gallo",
esattamente sopra al dosso rallenta-traffico)
Quella
vecchia lapide, in cui si ricorda l'albero della libertà, fu
posta nel 1904 quando Alfonsine fu governata per la prima volta da
una giunta di sinistra composta da socialisti e repubblicani. Durante la
ristrutturazione di una strada a cui diedero nome "via Giordano
Bruno", gli operai urtarono una vecchia radice rimasta sotto il
terreno della strada fin dai tempi dei loro nonni, quando in nome di
Mazzini e Garibaldi avevano fatto la rivoluzione sostenendo la Repubblica
Romana e piantando proprio in quel luogo l'"albero della
libertà".
La
Repubblica Romana fu annientata, l'Albero della Libertà fu abbattuto e i
sogni degli alfonsinesi riposti nel cassetto in attesa di tempi
migliori.
Il
tutto era durato appena 5 mesi da 9 febbraio del 1849 al 5 luglio dello
stesso anno,
Ma
in quei cinque mesi attorno a quell'albero di Alfonsine vi furono
matrimoni laici, in cui i promessi sposi girandovi attorno
così recitavano:
Sotto
quest’Albero / Di verdi foglie,
O cari amici, / Questa è mia moglie.
Sotto a quest’Albero / Bello e fiorito,
Questi, il vedete, / E’ mio marito
E
alla fine erano marito e moglie!
Quella
radice era tutto ciò che rimaneva di quell'albero e
lì sopra
fu posta la lapide.
|
Tutto
venne portato nel foro annonario presso le Pescherie di piazza
Monti, dove fu istituito un "magazzino del popolo" per
provvedere all'approvvigionamento della popolazione. Una parte di questi
beni di prima necessità fu lasciata all'ospedale, perché serviva
agli ammalati. Un'altra
parte di generi alimentari (prosciutti, farina) fu distribuita alla gente
radunata nella piazza. Il rimanente fu immagazzinato nel foro annonario,
per poter rivendere a prezzi calmierati, onde evitare speculazioni
possibili per i beni di prima necessità, che in quel periodo si sarebbero
potute verificare. Le
gente gridava "Viva il comunismo (secondo il
parroco, che scrisse le sue memorie qualche anno dopo), viva la
rivoluzione!" Qualcuno fra la gente esclamò: - “Oh se
durasse sempre così!"
La
rivoluzione come una festa
In
quella frase "Oh se durasse sempre così" s’intravede
lo stato di ebbrezza e felicità in cui si trovarono quegli uomini, donne
e ragazzi, per l'eccitazione di vivere una situazione collettiva di
euforia rivoluzionaria, e la consapevolezza nello stesso momento che non
durerà tanto, ma che importa, conta l'intensità delle esperienze forti,
e non la durata.
Si
videro in giro crocchi di persone non più preoccupate ma allegre: il
paese assunse un aspetto festivo, si discuteva facendo pronostici
sull'esito della rivoluzione in Italia. Alcuni ritornarono con la memoria
al 1849, quando i loro nonni, nella stessa piazza, avevano piantato
l'albero della libertà.
Dal
diario del parroco Don Tellarini: “Ed era uno spettacolo veramente
singolare e comico assieme vedere quella folla andarsene con sacchi sul
dorso, con prosciutti sotto le braccia e pane e vino ed ogni ben di Dio.
Anche un ragazzetto, soprannominato Baratieri, orfano di padre e di
famiglia veramente povera, che di giorno faceva servizi al parroco,
anch'egli chiese di andare a prendere la sua parte ed infatti si ebbe un
bel prosciutto.”
Anche
i repubblicani furono trascinati in quel clima che prefigurava la nascita
della Repubblica.
Pieno
d’orgoglio ed euforia il repubblicano Beno Gessi, veterinario, fu
inviato dal Comitato Rivoluzionario con la sua moto a Fusignano e nei
paesi vicini a diffondere la notizia della presunta rivoluzione.
Il
Gessi, col cognato Ferruccio Mossotti e il fratello Mino
Gessi, fu tra gli attivisti della rivolta di Alfonsine e qui
ebbe il compito di staffetta: tentò di convincere anche i fusignanesi a
sequestrare le armi per andare a Ravenna, a liberare gli amici circondati
nel cortile della casa del Popolo. Così anche a Fusignano la folla si
scatenò al grido
“Facciamo come quelli di Alfonsine!”
('Gli
avvenimenti fusignanesi della settimana rossa 9-10 e 11 giugno 1914,
ricordati dal sottoscritto che vi partecipò personalmente e con funzioni
direttive', s.l., marzo 1917, [p.7] di Pino Grossi)
|
| La
requisizione delle armi

Giacomo
Gessi
|
Ore
13
Il Comitato
rivoluzionario decise che si dovevano requisire tutte le armi. Aderirono
tutti, secondo la testimonianza di Alberani - monarchico e del maestro
Ballardini - repubblicano.
L'obiettivo era organizzare una spedizione su Ravenna per la liberazione
dei prigionieri della Casa del Popolo. Questa fu la voce che circolava.
In realtà a
Ravenna fu attuata una rapida uscita dalla cavalleria per disperdere
i dimostranti, i quali si erano sì rifugiati nella Casa del Popolo. Ma quando
i soldati furono passati, tutti uscirono tranquillamente.
(Alla sera,
terminata la rivolta, tutte le armi furono restituite)
|
| Minacce
ai Carabinieri e secondo incendio del Municipio

Caserma
dei Carabinieri,
in Corso Garibaldi.
Andò distrutta con l'ultima guerra.
|
ore
15
Una folla
sfilò minacciosa e armata di fucili davanti alla caserma dei
carabinieri in fondo al Corso Garibaldi
ore 16
In
Municipio intanto qualcuno cercava di salvare documenti e oggetti: erano
il sindaco Garavini, con il segretario comunale Avv. Samarelli e suo
figlio Pasquale, il capoufficio Massaroli, il rag. Melandri e pochi altri
cittadini, che riuscirono attraverso le fiamme a salvare tutti gli atti
dello Stato Civile e parte dell'Ufficio di Ragioneria; si salvò anche
interamente la Posta, il Telegrafo e l'Esattoria Comunale. Accortisi però
di ciò i rivoltosi ripresero ad incendiare.
Questa volta il fuoco si propagò fino al primo piano e il mezzanino.
Tutto andò distrutto. Alla sera (ore 21) caddero anche i tetti.
|
| Progetto
di assalire la caserma dei carabinieri |
ore
17
Un gruppo di
rivoltosi discusse come dare l'assalto alla caserma dei Carabinieri.
Coloro che abitavano vicino alla caserma (tra i quali il dott. Filose)
furono sollecitati ad allontanarsi per permettere di sparare dalle loro
case. Si decise che una delegazione di cittadini benestanti avrebbe dovuto
parlamentare con i carabinieri per ottenere il disarmo, prima di dare
l'assalto.
|
| Il
comportamento dei 13 carabinieri |
Durante
tutta questa giornata i tredici carabinieri non uscirono mai dalla
caserma. Erano troppo pochi e rimasero a difesa del presidio, che, avendo
due entrate, una anche sul retro verso l'argine del Senio, con fienile e
scuderia per i cavalli, necessitava di tutti i militi presenti per la
difesa. |
| Fine
della rivolta |
ore
20
Il Sindaco aveva ricevuto, fin dalle ore 17, dalla Confederazione del Lavoro l'ordine che lo sciopero
era sospeso dalla mezzanotte.
Nessuno del
Comitato Rivoluzionario se la sentì di propagare una tale notizia.
Fu
proprio il sindaco Garavini in prima persona a dichiarare alla folla,
anticipando di quattro ore l’orario, che da quel momento, ore 20, lo
sciopero era cessato, accompagnandolo con la frase "Siamo stati
traditi!"
(secondo il parroco Don Tellarini - ma non sembra credibile che l'abbia
detta proprio Garavini, molto più probabile che sia stato qualche altro
socialista o anarchico. Anche perché in un suo memoriale il Garavini
sostenne di aver fatto il possibile per contenere gli eccessi degli
scioperanti e cita, tra gli altri episodi, quello di aver annunciato per
le ore 20 la fine dello sciopero, tacendo il fatto che invece
l'indicazione era a partire dalla mezzanotte).
Questa
fu, infatti, la posizione di Mussolini, allora socialista rivoluzionario,
sostenitore e attivista alle manifestazioni e agli scioperi per la zona di
Milano, che accusò la Confederazione Generale del Lavoro di aver tradito
le aspettative del popolo.
La
gente però si sentì veramente tradita. Quasi tutti ad ogni modo
obbedirono e tornarono a casa tra i mugugni. Restarono i più arrabbiati
che però, vistisi in pochi, si dileguarono, consci forse di aver compiuto
enormi atti vandalici, oppure rassegnati al fatto che la festa era finita.
I negozi riaprirono, la piazza Monti era deserta.
Il giornale
"Pensiero Romagnolo del giorno dopo cercava di attenuare l'amara
delusione scrivendo: "Lo sciopero è finito, la rivoluzione è
cominciata!" Ma era un'affermazione ben lontana dal vero. |
|
La
Giunta Comunale si riunisce nelle scuole elementari
Commento
e condanna del Sindaco Camillo Garavini
per le violenze dei giorni
precedenti
|
Il
sindaco riunì la giunta municipale (socialista) e dichiarò, sebbene
avesse sostenuto le manifestazioni dello sciopero generale, “la
totale condanna degli eccessi inqualificabili che subito stigmatizzammo
senza poter intervenire a porre un freno”. Dichiarò
quindi
nemici giurati dell’Amministrazione coloro che si lasciarono andare ad
atti vandalici.
"Assistemmo
impotenti alla distruzione della Chiesa, della Pretura, del nostro Palazzo
Comunale, alle interruzioni delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche
e ferroviarie".
Denunciò il
mancato intervento della forza pubblica e raccontò del loro tentativo di
intervenire e delle minacce ricevute dai manifestanti; "fummo
financo minacciati per aver biasimato gli atti vandalici ed inconsulti che
la folla commetteva".
|
|
Arresti

Esuli
a San Marino
Profughi
politici a San Marino ritratti il 7 settembre 1914: da sinistra Brunetti
(repubblicano di Fabriano, Camillo Garavini (sindaco di Alfonsine,
socialista), Vincenzo Gironzi (repubblicano di Falconara), Umberto Bianchi
(socialista di Ravenna) ed infine i fusignanesi Renato Emaldi (studente
universitario, indipendente), e Giuseppe Grossi (impiegato comunale,
repubblicano)
|
Sabato
21 Giugno 1914:
200
soldati di cavalleria
Si
scatenò da parte dei conservatori e reazionari una campagna di
denigrazione contro le persone più in vista del Partito Repubblicano e
Socialista, come campagna in preparazione delle elezioni amministrative,
che si tennero ad Alfonsine e Ravenna, la domenica 26 luglio.
Camillo Garavini fu
ingiustamente accusato degli eccessi avvenuti nei giorni 10 e 11. E le
testimonianze del parroco Don Tellarini (e di altri) furono rilasciate, a
volte con qualche falsità e quindi non del tutto attendibili, certamente
anche per le elezioni imminenti.
La mattina di
sabato 21 giugno giunse da via Roma un reparto di ben 200 soldati di
cavalleria. I soldati alloggiarono in chiesa e il tenente colonnello
Riccordi prese il comando supremo. Iniziò così la retata. Furono
invase e perquisite le case di coloro per i quali c'era un mandato di
cattura. Molti però erano già in fuga. Riuscirono a fuggire il
sindaco Camillo Garavini a San Marino, Ferruccio Mossotti e Beno Gessi in
Svizzera.
Ci fu una serie
selvaggia di arresti, in tutto 19 (9 repubblicani, 5 anarchici, 5
socialisti). Tra gli arrestati, Giacomo Gessi,
fratello di Beno, che rimase in carcere a Pesaro per sei mesi.
|
|
Le
elezioni amministrative di Alfonsine

Municipio di Alfonsine durante
i lavori di ristrutturazione
|
La
domenica 26 luglio 1914 ci furono le elezioni amministrative comunali,
tutte giocate da parte dei conservatori sui fatti della “Settimana
Rossa”.
Ad Alfonsine
governava ancora una giunta socialista, anche se il sindaco era stato
costretto a fuggire a San Marino.
I Repubblicani
scelsero di astenersi non presentando alcuna lista per non intralciare gli
“amici” socialisti.
I liberali
conservatori non presentarono alcuna lista consapevoli di non poter
competere, e mirando all’insediamento di un commissario prefettizio,
come di fatto avvenne.
La vittoria della
lista dei socialisti, fatti passare per "sovversivi", fu totale:
30 consiglieri su 30.
|
|

Alberto
Alberani
primo sindaco fascista nel 1922
|
Ultimo
paradosso:
tutti
amnistiati per la nascita di una principessa.
I molti alfonsinesi
processati e condannati per quella rivolta, quelli che fuggirono in
Svizzera e quelli che andarono in carcere, dopo sei mesi, alla nascita di
una principessa reale, Maria Francesca di Savoia, ebbero un'amnistia generale e furono liberi.
La nuova amministrazione con a capo Camillo Garavini dopo
due anni fu commissariata. Riuscì comunque a realizzare la prima opera: la
ristrutturazione del Municipio.
Poi scoppiò la 1°
Guerra Mondiale.
Gli
alfonsinesi, di
leva o volontari, ("ah!...
quelli della settimana rossa") per punizione furono inviati quasi
sempre in prima linea.
Quando nel 1922
andò al potere il fascismo anche ad Alfonsine e il nuovo sindaco fu
Alberto Alberani (foto a destra), figlio dell’Anselmo Alberani già
citato, per molti di quelli della “Settimana rossa” fu dura, molto
dura.
Conclusione
Ad Alfonsine
durante la “Settimana Rossa” non ci fu neanche un morto. La violenza
fu simbolica, più contro le cose che contro le persone. Quella rivolta fu
un primo slancio creativo, un tentativo di essere al di là dei confini.
Ma per muoversi in
questa zona calda dell'evoluzione è necessaria una radicalità non più
ideologica e rancorosa (come c’era in gran parte in quei tempi), ma
biologica, cioè capace di attivare dall'interno del proprio corpo energia
e vitalità, (in alcuni momenti di festa di quei giorni sembra intravedere
che quegli alfonsinesi di un secolo fa in parte ci riuscirono).
Purtroppo
l'assortito banchetto delle ideologie anarchiche, socialiste e
repubblicane, che fece da cornice a questa rivolta, spinse in modo
accentuato verso il radicalismo ideologico.
Le successive
critiche e autocritiche cancellarono quasi completamente l'esperienza di
festa, carnevale e di voglia di vita che in parte aveva caratterizzato
quei giorni di metà giugno 1914.
La "settimana
rossa" passò alla storia come qualche cosa da dimenticare. Essa
fu rimossa completamente dalla memoria storica degli alfonsinesi di allora,
e di oggi.
|
 torna
alla pagina iniziale della Settimana Rossa di Alfonsine
torna
alla pagina iniziale della Settimana Rossa di Alfonsine
|

